#ReaCT2020 – Radicalizzazione e deradicalizzazione. Piste d’indagine (C. Sulmoni)
di Chiara Sulmoni, START InSight – Lugano
A quasi venti anni dai primi segnali dell’evoluzione di una scena jihadista tipicamente europea, i dati quantitativi a disposizione permettono di disegnare le tendenze del cosiddetto terrorismo islamista ‘homegrown’. La radicalizzazione è invece più complessa da misurare; se i numeri degli estremisti segnalati o monitorati, da un lato, permettono di avere un’idea dell’ampiezza del fenomeno, dall’altro non sono indicativi del grado di pericolosità degli individui né suggeriscono possibili strade da percorrere in materia di contrasto. Per questo, è fondamentale prestare attenzione ai ‘meccanismi’ e ai contesti che favoriscono l’adesione e il reclutamento, incluse le difficoltà incontrate da chi si muove sul territorio nella prevenzione e nella deradicalizzazione. Si tratta di un passaggio essenziale e di un richiamo alla responsabilità anche per la politica, che è tenuta a preparare il terreno legislativo e istituzionale per la messa in atto di strategie efficaci.
I LIMITI DEI NUMERI
Lo Stato Islamico ha saputo mobilitare un numero inedito di individui in ogni parte del mondo; decine di migliaia nella sola Europa, tra foreign fighters, aspiranti terroristi, reclutatori per la causa jihadista, sostenitori e simpatizzanti del Califfato -i cosiddetti radicalizzati. Nel maggio del 2017, a seguito dell’attentato alla Manchester Arena, i media inglesi rivelarono la portata della minaccia riassunta nella cifra di 23’000 estremisti jihadisti noti all’intelligence, fra cui un pool di 3’000 soggetti considerati pericolosi e monitorati nell’ambito di quelle che all’epoca erano 500 operazioni contemporanee (salite nel frattempo ad 800). Sono numeri importanti ed utili per capire l’ampiezza del fenomeno; tuttavia, non sono indicativi del rischio reale poiché i nomi entrano ed escono dalle categorie prioritarie a seconda di criteri e valutazioni variabili. In Francia nel 2018 un Gruppo di lavoro parlamentare incaricato di migliorare l’efficacia delle cosiddette Fiches S, preoccupato per la confusione e gli effetti controproducenti della focalizzazione politico-mediatica attorno a quello che è solo uno strumento di raccolta delle informazioni, ha ritenuto di dover specificare che non si tratta di un indicatore della pericolosità delle persone né, tantomeno, è destinato al monitoraggio della radicalizzazione (che nella sezione specifica, conta circa 20’000 schedature, fra le quali più di 9’000 cosiddette “attive”). A fronte quindi di cifre imprecise, un segnale più significativo del pericolo con cui ci confrontiamo può venire dalla quantità di attentati sventati: Europol ne conta 16 nel solo 2018; la Gran Bretagna 25 dal marzo 2017 (inclusi 8 attentati pianificati dall’estrema destra); mentre in Francia, dal 2013, ci sarebbero stati 60 tentativi. La volontà di colpire l’Europa persiste. Ma qual è la realtà della sfida?
DE-CIFRARE LA RADICALIZZAZIONE: UNA SFIDA COMPLESSA
La realtà della sfida non ha sempre a che vedere con le preoccupazioni dell’opinione pubblica, gli argomenti dei media o i temi della politica che, un po’ per dovere e un po’ per fini elettorali, tende a concentrarsi sugli aspetti securitari e a breve termine. A raccontare la posta in gioco è, spesso, chi si confronta a livello personale con il radicalismo oppure opera sul territorio nella prevenzione e nel contrasto. Con l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili proprio in questo senso, a partire dal 2017 ho avviato un’inchiesta giornalistica in cinque paesi europei -Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Olanda e Italia- confluita in parte in una serie di reportages d’approfondimento per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)[1]; in ogni nazione il dibattito segue traiettorie distinte e le opinioni attorno a cause e soluzioni possono variare anche di molto; tuttavia l’accostamento di voci permette di allargare l’analisi ai contesti, che gran parte delle analisi, incentrate sugli individui o le dinamiche interne di gruppo, tende a trascurare. Ma è utile ricordare come la radicalizzazione non costituisca un mondo parallelo; essa prende avvio dentro la società e in relazione con essa. Naturalmente un percorso a ritroso sulle tracce delle ‘tensioni’ che possono favorire l’estremismo implica un’ampia discussione attorno a tematiche quali il ruolo e il senso di integrazione, emarginazione sociale, identità, laicità dello Stato, politica estera- che possono sembrare aleatorie, a fronte di un pericolo reale e letale come quello del terrorismo. È fondamentale però saper fare le giuste distinzioni e non sovrapporre le questioni di intelligence o difesa, alla comprensione dei processi di radicalizzazione (partendo dal presupposto che comprendere è già prevenire).
LE PROSSIME SFIDE
Prevenzione e deradicalizzazione occupano uno spazio rilevante -come concetti e almeno nelle intenzioni- nel quadro delle varie strategie di controterrorismo e contrasto all’estremismo violento emanate gradualmente negli ultimi quindici anni da Unione Europea, Nazioni Unite e singoli paesi, tanto da aver contribuito alla nascita di un intero settore che non è stato esente da esperienze fallimentari e da polemiche. Un’analisi apparsa nella rivista specializzata Perspectives on Terrorism (2019)[2] segnala una discontinuità -nelle due direzioni- tra la ricerca accademica sulla deradicalizzazione, la formazione e la realtà degli operatori che si occupano degli interventi; è un’osservazione preoccupante di cui tenere conto, considerando le sfide che si presentano alle porte. Nell’autunno del 2019, la fragilità degli equilibri sul fronte geopolitico in Siria e in Iraq ha richiamato l’attenzione su un problema che l’Europa aveva provato a lasciare in eredità al Medio Oriente: la questione spinosa di come gestire gli jihadisti con le loro consorti più agguerrite, che dai campi di detenzione hanno lanciato strali contro l’Occidente. Al di là di tutte le difficoltà che il rimpatrio e i processi possono presentare a livello legislativo e giuridico -a cominciare dalla raccolta delle prove a carico- a destare comprensibilmente preoccupazione è soprattutto il pensiero della permanenza in un ambiente, quello carcerario, già sotto pressione per la presenza di radicalizzati interni. Senza contare l’incognita sulla modalità e il successo di un loro reinserimento in società. L’attentato del 29 novembre che ha avuto il suo tragico epilogo sul London Bridge, dove un aspirante terrorista rilasciato a metà della pena ha ucciso due volontari di un programma di reintegrazione per detenuti promosso dall’Università di Cambridge, ha prepotentemente spinto la questione in cima alla lista delle priorità. Nel corso dei prossimi anni, un numero sempre maggiore di estremisti (jihadisti) sarà libero e il timore che simpatizzanti di gruppi terroristici, ex-combattenti, reclutatori e propagandisti possano tornare attivi e agire con maggiore determinazione, è tutt’altro che infondato. Del tema si discute da tempo ma il caso di Usman Khan, che ha apparentemente ‘raggirato’ il sistema, ha portato diversi nodi al pettine e permette di mettere a fuoco alcuni argomenti importanti sui quali ragionare, non solo in Inghilterra. Al di là di aspetti prettamente giudiziari come la durata delle pene e le condizioni della libertà vigilata, a contare, nell’ottica di limitare il pericolo di recidiva o di una più profonda radicalizzazione, è la gestione di questo tipo di reato dentro l’ecosistema carcerario (che, fra gli esperti, non fa l’unanimità); la validità dei metodi di valutazione del rischio (che richiedono aggiornamenti continui); la preparazione del personale (inclusa quella dei quadri); la coerenza e continuità fra programmi di ‘recupero’ e reintegrazione prima e dopo il rilascio. Sono aree collegate, che necessitano di azioni e visioni coordinate.
LA DERADICALIZZAZIONE FRA ASPETTATIVE E REALTÀ
I fatti di Londra in particolare hanno aperto una discussione attorno all’efficacia (o meno) della cosiddetta deradicalizzazione. L’interrogativo è lecito ma le aspettative di politici, media, ricercatori e cittadini sono diverse e possono confondere la linea di dibattito. Il termine elusivo di deradicalizzazione viene da tempo sostituito dal concetto di ‘abbandono della violenza’, che non implica una rinuncia all’obiettivo ideale -cioè, che l’individuo possa sganciarsi da un’ideologia radicale; implica invece -o dovrebbe farlo- la consapevolezza di come il percorso sia graduale, di lunga durata, incerto e costellato di priorità (la sicurezza della collettività innanzitutto). Come in tutti i processi che affrontano questioni di identità sociale, le incognite e le variabili sono molte e dipendono dall’individuo stesso -dalla volontà di rivedere le proprie scelte- e dalle circostanze esterne. Nella migliore delle ipotesi, l’approccio di questi ‘programmi’ consiste nel ‘mentoring’, vale a dire la presa in consegna del soggetto, che viene seguito passo per passo da un punto di vista psicologico, teologico, ideologico, incluso un accompagnamento verso il reinserimento nella società. La complessità di un intervento di questo genere è anche organizzativa, poiché impone una collaborazione di carattere multidisciplinare e con partner di vario genere: autorità incaricate della libertà vigilata, polizia, intelligence, professionisti inquadrati in ONG e istituzioni attive nel campo. In Europa si sta ancora sperimentando e una ‘ricetta’ che si possa trasferire da una realtà all’altra non esiste, mentre la scarsità dei dati a disposizione, insieme alla mancanza di un metodo coerente e affidabile di valutazione non permettono di misurare concretamente la riuscita di iniziative che sono peraltro avvolte dalla confidenzialità; di conseguenza, poiché a venire a galla con certezza sono gli insuccessi, soprattutto in occasione di eventi terroristici, il rischio in cui si incorre è di ‘liquidare’ anni di esperienza pregressa e di studi. Per questa ragione, è importante affrontare l’argomento in modo costruttivo, prendendo in considerazione non solo le buone pratiche ma anche gli ostacoli che possono compromettere l’incisività dei vari interventi; un esercizio utile soprattutto per quei paesi che, ancora poco toccati dal fenomeno, hanno la possibilità di evitare passi falsi. Una delle principali difficoltà consiste nella scelta di mentori/practitioners preparati e credibili sia agli occhi del ‘sistema’ che dei loro ‘assistiti’; le due cose non coincidono necessariamente, in parte anche a causa dei limiti imposti dalla collaborazione con il governo e le sue istituzioni. Il problema si può riscontrare anche nel settore della prevenzione. In ragione di questa dimensione politica, è fondamentale riflettere con attenzione sui criteri di selezione, che oltre agli obiettivi strategici dovrebbero tenere conto anche alla realtà che si deve affrontare sul territorio. Sottovalutare questo aspetto -che ha la profondità di un dilemma- può avere delle ripercussioni negative sui progetti e sui fondi, che sono essenziali per la riuscita e la sostenibilità di un settore in evoluzione, che richiede un impegno a lungo termine.
Deradicalizzazione e prevenzione sono campi dove sarà necessario investire in modo oculato, facendo in modo che le misure di sicurezza a corto termine siano allineate con gli obiettivi a lungo termine, cioè il contenimento del fenomeno -parlare di sconfiggere il terrorismo non è realistico ma impegnarsi per combatterne le cause e la diffusione sì-. Non esistono soluzioni su misura né garanzie di successo ma sarebbe utile, oggi, guardare in modo costruttivo a pratiche e tentativi -anche fallimentari- dei paesi con maggiore esperienza nel settore, sia in materia di regime di detenzione che di deradicalizzazione. Con tutti questi aspetti dovranno confrontarsi non i singoli partiti ma l’intera classe politica. Recentemente il Vice-commissario dell’anti-terrorismo inglese Neil Basu, chiedendo la collaborazione di “bravi” ricercatori, criminologi e sociologhi, ha dichiarato che nella battaglia contro l’estremismo violento l’approccio securitario (polizia e servizi di sicurezza) non è più sufficiente. È essenziale che questo dialogo avvenga anche a livello istituzionale, in modo che la politica possa preparare un terreno legislativo proficuo per la messa in atto delle iniziative necessarie ad affrontare i problemi sul terreno e spiegare l’importanza e i risvolti di questo impegno all’opinione pubblica in modo chiaro, competente e convincente.
[1] https://www.osservatorioreact.it/indagine-radicalismo-europa/
[2] Koehler, D. e Fiebig, V. Knowing What to Do: Academic and Practitioner Understanding of How to Counter Violent Radicalization, Perspectives on Terrorism, Volume 13, Issue 3, June 2019







































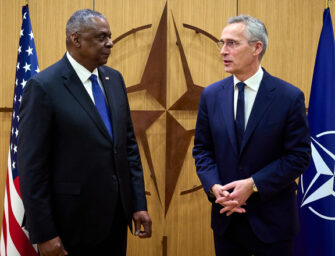






































There are no comments
Add yours