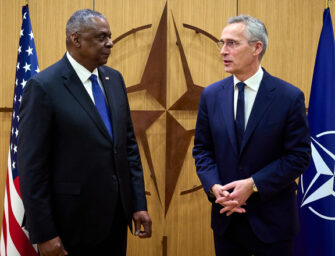Chaos a Capitol Hill: cosa è mancato
di Luca Tenzi, Security and Resilience Strategist e Andrea Molle, START InSight
Scarica l’analisi completa in PDF
La storia ci insegna che l’assalto coordinato al Campidoglio, avvenuto mercoledì 6 Gennaio 2021 a Washington DC, è stato tutto fuorché imprevedibile. Nonostante si tratti di eventi poco conosciuti al pubblico, il Campidoglio è stato in passato l’obiettivo di diversi attacchi. Nel 1954, ad esempio, un gruppo di separatisti provenienti dallo Stato libero associato, cioè un territorio non incorporato degli Stati Uniti, aprirono il fuoco all’interno dell’edificio, ferendo cinque membri del Congresso. Nel 1998, invece, un singolo individuo armato riuscì a superare tutti i controlli di sicurezza del Campidoglio uccidendo due poliziotti prima di essere fermato. Infine, il Campidoglio fu probabilmente il quarto obiettivo, fortunatamente non raggiunto, dei dirottatori del 9/11 2001. Da allora, la possibilità di un attentato terroristico all’edificio è stata presa seriamente in considerazione. O almeno avrebbe dovuto esserlo.
Nella sottovalutazione della minaccia, ha sicuramente inciso il fatto che nella storia americana recente non si erano mai avute delle dimostrazioni di tale violenza dirette verso un luogo governativo. Neppure durante manifestazioni di protesta, vere e proprie rivolte, contro la guerra del Vietnam i dimostranti presero d’assalto i luoghi simbolo dello Stato, men che meno il Campidoglio. Infine, nemmeno le più recenti dimostrazioni organizzate del movimento Black Lives Matter, pur arrivando fino alla soglia dei palazzi del potere americano, avevano mai infranto la sottile linea di demarcazione tra la disubbidienza civile e l’atto di sovversione nei confronti di un governo legittimo e democraticamente eletto.
Tuttavia, tutto faceva presagire che non sarebbe stata una manifestazione come le altre. Nei giorni precedenti al 6 gennaio, si erano registrati molti segnali che avrebbero dovuto allarmare la comunità dell’intelligence americana. Fonti di open-source intelligence avevano lanciato l’allarme che i sostenitori di Donald Trump stavano condividendo, sui social media, piani per la giornata e, tra le discussioni monitorate, vi erano thread sospetti, tra i quali, ad esempio, una discussione sui modi per introdurre illegalmente armi nella Capitale federale. In casi come questo, non solo di semplici manifestazioni di protesta ma con la concreta possibilità di episodi violenti, le agenzie locali e federali, in totale circa una dozzina, avrebbero dovuto prestare molta attenzione alla pianificazione e al coordinamento delle operazioni. La raccolta di informazioni e la pianificazione delle misure di sicurezza preventiva avviene, di norma, sotto la guida dell’FBI o dell’NSA (National Security Agency), ma non è chiaro quanto di tutto ciò sia avvenuto nel caso del 6 Gennaio.
Va sottolineato che la capitale Americana, Washington DC, vive di vita propria relativamente alle forze di sicurezza, con una moltitudine di agenzie locali, statali e federali che si occupano della protezione dei simboli e dei rappresentati del governo. Come da protocollo, la sicurezza è stata inizialmente gestita dalla sola Capitol Police, una forza di polizia di circa 2.000 membri sotto il controllo diretto del Congresso e dedicata unicamente alla protezione del Campidoglio. Il Capo della Capitol Police, che viste le forti pressioni politiche si è dimesso con decorrenza dal 16 Gennaio, ha dichiarato di aver presentato la richiesta di rinforzi ben due giorni prima della rivolta, avendo ricevuto e esaminato l’intelligence che indicava che la manifestazione sarebbe stata più grande e potenzialmente più violenta di quanto previsto. Per ragioni che ancora oggi rimangono poco chiare, gli altri elementi del vasto apparato di sicurezza del governo federale degli Stati Uniti hanno ignorato la richiesta e non sono intervenuti per tempo.
Il periodo di transizione tra il governo uscente e la nuova amministrazione ha influenzato il processo decisionale. Il fatto che posizioni chiave, occupate ad interim da dirigenti prossimi a lasciare, ha sicuramente rallentato o addirittura indebolito la forza delle decisioni operative e tattiche. Ciò emerge anche dall’analisi delle tempistiche decisionali. La timeline degli eventi sembra prendere sempre più forma lasciando intendere che gli errori siano stati molti. Un funzionario della Difesa ha ad esempio dichiarato che il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha richiesto l’invio della Guardia Nazionale intorno alle ore 14:00 e cioè circa 45 minuti dopo che gli assalitori avevano superato la prima barricata del perimento esterno di sicurezza dell’edificio. Non è chiaro perché il sindaco lo dovesse fare, e non piuttosto il Capo della polizia del Campidoglio Steven Sund, a riprova del fatto che le linee gerarchiche, molto particolari, della capitale hanno sicuramente aggravato la confusione. Il segretario alla Difesa ad interim, Chris Miller, ha poi attivato la Guardia Nazionale, ma solo circa 30 minuti dopo la richiesta ricevuta dal sindaco e alla quale si sono anche aggiunti reparti tattici (SWAT) di polizia provenienti dagli Stati confinanti. A quel punto, purtroppo il Campidoglio era ormai indifendibile. Nonostante la presenza di un sottile perimetro di sicurezza esterna, non era stato previsto, apparentemente, nessuno perimetro di sicurezza all’interno dell’edificio, eccezione fatta per lo schieramento di alcuni agenti a difesa dei luoghi più importanti. Nessun corridoio era stato bloccato e una volta raggiunto l’interno, gli assalitori hanno potuto girare liberamente nell’edificio, inseguiti dalla polizia ormai in preda alla confusione.
Durante la fase interna dell’assalto, nella Rotunda, l’iconica sala circolare situata sotto la cupola del Campidoglio, sono state distribuite maschere antigas. È noto che la polizia abbia anche usato spray al peperoncino e gas lacrimogeni per rallentare il movimento dei manifestanti, trovandosi chiaramente in inferiorità numerica. Allo stesso tempo, il servizio segreto procedeva all’evacuazione del vicepresidente Mike Pence e, questa volta la polizia, dei diversi membri del Congresso tra cui la Speaker Nancy Pelosi. Le forze di sicurezza hanno anche cercato di barricare le porte con espedienti di fortuna, usando ad esempio i mobili degli uffici e dell’aula parlamentare. Una credenza, ad esempio, è stata spinta davanti alle porte dell’aula, mentre i parlamentari si nascondevano sotto le scrivanie in attesa di essere estratti.
A vent’anni dal 9/11, si stima che il budget annuale del dipartimento della sicurezza del Campidoglio sia triplicato e si assesti sui $450 milioni. Ma allora cosa non ha funzionato nella difesa del Campidoglio? Tra le cose importanti da sottolineare, la prima è l’impreparazione della Capitol Police nel gestire una situazione di vera e propria guerriglia nel Campidoglio che si sovrappone a una debolezza strutturale dell’edificio. Si tratta di una lacuna fondamentalmente addestrativa, ma che non lascia molto spazio a soluzioni alternative. Gli agenti sono infatti principalmente addestrati allo scopo di tenere eventuali manifestanti lontani dai gradini esterni del Campidoglio e proteggere il complesso alla stregua di una cittadella. L’obiettivo di difendere i gradini è giustificato dal fatto che il complesso del Campidoglio, risalente al 19° secolo, è caratterizzato dalla presenza di molte porte e finestre. È difficile pertanto pensare che una forza di polizia, sebbene numerosa, possa difenderle tutte contemporaneamente. Una volta conquistati i gradini, come purtroppo prevedibile, gli assalitori hanno avuto gioco facile per trovare una via di ingresso nell’edificio. La seconda debolezza, questa volta operativa, è che la Capitol Police dispone di piani di contingenza unicamente per quelle che vengono definite, legalmente, come “attività previste del Primo Emendamento” e cioè attività di protesta, anche moderatamente violenta, ma che non si configurano come un attacco di stampo terroristico o come un’operazione di guerriglia.
Le dimostrazioni di protesta e gli atti di disubbidienza civile dei sostenitori repubblicani erano state certamente ipotizzate, e in un certo senso date per scontate per la dialettica confrontazionale impostata dal Presidente uscente, ma la violenza che si è risolta in un vero e proprio assalto ha sorpreso tutti gli esperti sia nazionali che stranieri. Tale veemenza fisica e dialettica, ha scioccato il mondo proprio per la facilità con cui è stato violato un luogo che veniva reputato tra i più sicuri in assoluto e che invece ha dimostrato una imperdonabile debolezza.
Nonostante la presunta esistenza di molteplici meccanismi di contingenza, la sicurezza è stata evidentemente mal progettata, insufficiente, e affidata a una forza di polizia inadeguata al compito. La risposta è apparsa del tutto improvvisata al punto che i direttori dei Dipartimenti di Giustizia, Difesa, e Homeland Security hanno avviato un rigoroso procedimento di inchiesta relativo alle mancanze delle proprie agenzie durante l’assalto.
Sorvolando sulla dinamica del movimento di folla, se coordinato o meno, e lasciando per un momento da parte un’analisi più precisa della gestione da parte delle forze dell’ordine preposte all’intelligence e alla gestione dei facinorosi, ciò che stupisce è la fragilità delle difese fisiche dell’immobile. Anche le risorse umane, cosi come il materiale individuale e di gruppo a disposizione delle forze preposte alla difesa fa ben capire che lo scenario che si è realizzato davanti gli occhi, e le telecamere dei media e dei social media, non era mai stato veramente preso in considerazione.
Per misure fisiche si intendono sia gli elementi di tipo architettonico a difesa della struttura che i sistemi meccanici o manuali che avrebbero dovuto impedire, ritardare o anche solo limitare l’accesso all’edificio da parte del gruppo più violento dei manifestanti. Misure che nel mondo degli esperti della security e protezione di luoghi sensibili vengo riassunte nel paradigma delle 5D (deter, detect, deny, delay, defend), modello che è ormai considerato best practice da tutte le agenzie di sicurezza sia pubblica che privata. La loro mancanza lascia molto perplessi, proprio perché negli Stati Uniti, più che altrove, le misure di sicurezza relative alla protezione dei luoghi simbolo del governo sono notevolmente aumentate dopo gli eventi del 9/11. Nel “dopo 9/11”, tutti gli obiettivi sensibili, sia su suolo americano che all’estero come le sedi diplomatiche, hanno subito un completo restyling di sicurezza anche grazie all’incremento esponenziale dei budget dedicati. Le ambasciate Americane nel mondo vengo oggi prese ad esempio proprio per le loro misure di sicurezza, teutoniche e draconiane. Misure architettoniche, restyling urbanistico, nuove soluzioni tecniche, e presenza costante di personale armato sono oggi diventati la norma. L’uso dei concetti di prevenzione del crimine attraverso la progettazione ambientale (Crime prevention through environmental design, CPTED) sono tra gli elementi chiave della rivoluzione stilistica della sicurezza, che vede la sua apoteosi nella sede diplomatica americana a Londra. Qui l’approccio multi-disciplinare per sviluppare un deterrente al comportamento criminale è stato portato quasi al parossismo trasformando l’Ambasciata in una fortezza quasi inespugnabile.
Lo stesso non si può invece dire per molti dei luoghi chiave della politica americana nella capitale federale. Il Campidoglio rimane, come tanti altri luoghi governativi, parzialmente aperto al pubblico e questo lo rende un soft target. I visitatori, durante le visite guidate ma anche durante incontri con i propri rappresentanti governativi, possono tranquillamente osservare e raccogliere informazioni e muoversi quasi liberamente all’interno dell’edificio. Dove non arrivano le visite dirette lo fa internet con siti specialistici che pubblicano mappe estremamente dettagliate del Campidoglio. Mappe che vengono anche aggiornate ogni qualvolta si fanno delle modifiche o vi sono delle ristrutturazioni. Dopo i fatti del 6 Gennaio, persino le misure di sicurezza e gli spostamenti del Vice Presidente sono stati studiati, analizzati e mostrati dai mass media.
Un primo elemento di debolezza è che, pur avendo in passato stabilito una prima linea di difesa in occasione delle manifestazioni del movimento Black Lives Matter, sembra che in questo caso non si sia pensato di fare lo stesso utilizzando barriere antisfondamento e anti-scavalcamento. Di fatto le barriere usate il 6 Gennaio erano di tipo classico, come quelle usate solitamente per direzionare le folle, come nel caso del pubblico di un concerto, e non certo le barriere viste a difesa del Campidoglio e della Casa Bianca successivamente alle proteste collegate alla morte di George Floyd. In quell’occasione la reazione dell’apparato di sicurezza fu probabilmente anche esagerata. Va ricordato che allora il presidente Trump fece costruire una cancellata molto alta a protezione della Casa Bianca e anche che durante le proteste vi fu una famosa photo ops dove si vedevano i manifestanti rimossi manu militari dalla Guardia Nazionale. Paradossalmente, la cosa fu accolta con orrore da molti osservatori perché, a loro dire, la Casa Bianca deve rimanere un simbolo accessibile al popolo che ha diritto costituzionalmente a manifestare in protesta.
Un secondo aspetto che ci sorprende è la presenza di alcuni punti d’ingresso mal protetti e facilmente accessibili. Parliamo, ad esempio, di come le finestre ai piani inferiori non fossero protette né anti-sfondamento. Dalle immagini diffuse abbiamo potuto osservare come solo un limitato numero di vetri sulle porte principali lo fossero, e altre siano state sfondate con dei semplici oggetti disponibili sul campo, es. sedie o sbarre di metallo. Questo ha facilitato l’accesso di alcuni elementi sovversivi che hanno poi permesso di dare indicazioni e sicuramente liberare porte che fossero state chiuse dall’interno. Le porte interne, per esempio, non erano anti-sfondamento, né i vetri erano balistici. L’immagine degli agenti a difesa della sala del senato con le armi in pugno, con quello che sembra essere un armadio a difesa della porta, ce lo conferma. Così come anche la morte della manifestante a causa di un colpo sparato attraverso una porta finestra da parte di un agente di polizia. Da mesi inoltre il Campidoglio è parzialmente ricoperto da impalcature per lavori di conservazione delle facciate. Impalcature mal protette che hanno fatto da torre temporanea d’assalto, facilitando l’accesso ai piani superiori fino al tetto e fornendo armi improprie agli aggressori. Impalcatura e cantiere che non erano protetti o difesi e, sembra, di facile accesso.
In conclusione, se la democrazia ha dimostrato grandi capacità di tenuta, la sicurezza ha fallito e in modo spettacolare. L’inadeguatezza dimostrata dalla mancanza di pianificazione operativa e fisica, oltre che dalla presenza di problemi sistemici nella catena di comando dell’apparato di sicurezza di Capitol Hill non può che far riflettere sul fatto che gli Stati Uniti sono sostanzialmente impreparati ad affrontare una minaccia eversiva interna ad opera di individui appartenenti alla maggioranza della popolazione – cioè rappresentata da cittadini americani di classe medio-bassa e di razza caucasica.
Questo non solo a causa dei ritardi nella comunità dell’intelligence nell’adeguare la propria percezione del rischio a un target che non sia lo stereotipo del jihadista straniero, di origine medio-orientale, ma anche e forse soprattutto per la presenza di un vizio ab originem racchiuso nella stessa Costituzione del paese. Il primo e il secondo emendamento garantiscono rispettivamente infatti, ai cittadini ed ai residenti permanenti, il diritto ad esprimere anche in modo aggressivo la propria opinione e di possedere armi da fuoco, organizzandosi nella forma di milizie per rispondere alle minacce esterne e interne comprese, nell’immaginario collettivo, quelle provenienti da un governo considerato dittatoriale. Questa miscela infiammabile ha contribuito a causare i fatti del 6 Gennaio e contribuisce anche oggi a fare di obiettivi high profile, come il Campidoglio ma anche la stessa Casa Bianca, dei soft target.
Come vi è stato un prima e dopo 9/11, vi sarà un prima e dopo 1/6. Laddove i diritti costituzionali sanciti dal primo e secondo emendamento non potranno probabilmente essere modificati, possiamo ipotizzare e auspicare che i movimenti nazionalisti e le milizie diventeranno osservati speciali. Avremo inoltre discussioni, anche animate, su quali possono e dovranno essere le misure di sicurezza per gli edifici governativi aperti al pubblico, in primis proprio il Campidoglio. Discussioni che a ben vedere sono già iniziate nei giorni seguenti all’assalto, quando la Speaker Democratica Nancy Pelosi ha ordinato, non senza proteste e defezioni, che Capitol Police introducesse dei controlli simili a quelli aereoportuali anche per l’accesso di parlamentari e senatori al Congresso.
Photo by LOGAN WEAVER on Unsplash
Formazione degli Imam in Europa. I limiti della proposta
di Andrea Molle
In seguito ai recenti attentati di Nizza e Vienna, Macron si incontra con i capi di stato e di governo di Austria, Olanda, Germania e ai vertici della UE per promuovere una serie di iniziative comuni in tema di controllo e prevenzione della minaccia terroristica, di riforma degli accordi di Schengen e di irrobustimento delle frontiere esterne dell’Unione. Tra le prime conseguenze dell’incontro spicca una vecchia ossessione francese: delineare un sistema di formazione e certificazione statale degli Imam, o magari a livello sovra nazionale, come rilanciato qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. In questo modo, secondo la teoria francese che sta facendo breccia nelle istituzioni dell’Unione, si ridurrebbe il rischio di ingerenze straniere e di infiltrazioni di elementi radicalizzati, e radicalizzanti, nel tessuto religioso islamico europeo. Si tratta di un approccio tipicamente transalpino, che in Francia è applicato con discreto successo in diversi settori della società civile: dalle professioni alle federazioni sportive, passando per le scuole di formazione. Ma l’estensione di questo principio alla religione è una sostanziale novità persino nel panorama francese. Se ad una prima lettura può sembrare una buona idea, vi sono ragioni per ritenere questa svolta molto più pericolosa del problema che si propone di risolvere. Quello della formazione interna, con certificazione statale, dei leader religiosi è un tema molto spinoso. Da un lato è certamente vero che sono le stesse comunità a volersi dotare, “dal basso”, di percorsi di formazione che prescindano da strutture, gerarchie e supporti economici riconducibili a paesi stranieri. Ma dall’altro è altrettanto vero che qualora lo Stato si facesse soggetto agente, in posizione dominante, dei percorsi di formazione e soprattutto diventasse l’unica fonte di legittimità, questi stessi processi sarebbero vissuti come l’ennesimo tentativo di ingerenza in quelle stesse comunità laddove la radicalizzazione è proprio una reazione alla percezione di marginalizzazione, deprivazione relativa e aumento del controllo statale. Soprattutto se il sistema non venisse ad essere esteso a tutte le religioni praticate, incluso il Cristianesimo, questa ingerenza finirebbe per incrementare il rischio di radicalizzazione.
se ad una prima lettura può sembrare una buona idea, vi sono ragioni per ritenere questa svolta molto più pericolosa del problema che si propone di risolvere
Una svolta decisamente statalista e per certi versi ipocrita se applicata dagli stessi governi che la condannano quando a farlo sono Russia e Cina, verrebbe inoltre a scontrarsi con due realtà già chiare a chi si occupa di questi fenomeni. In primo luogo è puro wishful thinking che la centralizzazione risulti in una diminuzione del rischio di radicalizzazione. Il primo problema di questa proposta, come affermano oggi i leaders dell’Islam francese, è che la presenza di un sistema di formazione degli “Imam di Stato” non beneficerebbe di alcuna legittimazione teologica da parte del mondo mussulmano. Il secondo limite della proposta è che molto difficilmente porterebbe alla scomparsa di gruppi guidati da leader non riconosciuti dal governo, magari sponsorizzati da paesi stranieri, la cui autorità religiosa sarebbe più legittima. É piuttosto probabile che finirebbero per tramutarsi in gruppi underground maggiormente suscettibili alle infiltrazioni e ancora di più difficile monitoraggio.
un sistema di formazione degli “Imam di Stato” non beneficerebbe della legittimazione teologica da parte del mondo mussulmano
A questi limiti oggettivi va aggiunto che l’assunto secondo cui i luoghi religiosi sono deliberatamente creati come luoghi di radicalizzazione è solo un mito, che riposa sulla concezione francese di religione come fatto privato irrazionale, intrinsecamente prono alla violenza. Questa è un’idea molto diffusa politicamente, ma che non è affatto corroborata da evidenze scientifiche. La letteratura scientifica suggerisce piuttosto che i luoghi di culto, una risposta di per sé sana alla crisi sociale delle seconde e terze generazioni dell’immigrazione extra-europea, siano diventati con il tempo facile preda del radicalismo proprio perché ignorati, quando non apertamente osteggiati, dai governi occidentali. Sembrerebbe insomma che l’ortodossia francese in tema di separazione tra Stato e Chiesa sia una concausa più che una soluzione al problema del radicalismo. Questo è quanto suggerisce anche Chems-Eddine Hafiz, Rettore della Grande Moschea di Parigi, che insiste su come il problema fondamentale sia che la mancanza di tutela dell’Imam e la mancata professionalizzazione della sua figura producano la necessità di ricorrere a figure e soprattutto risorse finanziarie straniere.
sembrerebbe che l’ortodossia francese in tema di separazione tra Stato e Chiesa sia una concausa più che una soluzione al problema del radicalismo
Una recente proposta di legge patrocinata dallo stesso Presidente francese sembrava andare nell’ottima direzione di integrare finalmente l’Islam, e le altre religioni minoritarie, in un quadro di accettazione della dimensione pubblica ed educativa della religione abbandonando l’ortodossia laicista, basata appunto sul mito della secolarizzazione. È quindi ancor più palese che la proposta odierna ci riporterebbe indietro di almeno un decennio nella lotta alla radicalizzazione. Invece che ricorrere ai monopoli di stato, una soluzione migliore e più coerente con le conoscenze scientifiche di settore potrebbe essere piuttosto quella di liberalizzare, aumentando la possibilità per gruppi e soggetti indipendenti, tendenzialmente moderati, di accedere al “mercato religioso” francese.
la proposta odierna ci riporterebbe indietro di almeno un decennio nella lotta alla radicalizzazione
Questi elementi finirebbero quasi certamente per isolare le esperienze più estremiste e violente tramite i normali meccanismi di concorrenza di libero mercato. Sembra invece che Macron, insieme a molti suoi colleghi Capi di Stato, sia caduto nella trappola tesa dai recenti attentati di Nizza e Vienna. Laddove l’Austria pensa addirittura di mettere fuori legge l’Islam politico, ignorando quanto esso sia estremamente difficile da definire e operazionalizzare, e la riunione dei ministri dell’Interno dell’Unione preannuncia una nuova stretta sui controlli e sulla propaganda online, a nostro avviso il vero vincitore è proprio il radicalismo islamico. In linea con gli obiettivi più classici del terrorismo, cioé provocare una reazione eccessiva e scomposta guidata da logiche di politica interna, temiamo che il nuovo corso dell’Europa finirà per beneficiare solo il radicalismo incrementandone il bacino di reclutamento.
CORONAVIRUS ADESSO. I NUMERI CHE CONTANO, IL MESSAGGIO CHE DEVE PASSARE E IL CASO ITALIA. LE VALUTAZIONI DI ANDREA MOLLE.
Nel corso delle ultime settimane Andrea Molle (Chapman University, USA e ricercatore associato START InSight) ha seguito l’andamento della pandemia di COVID19 e condiviso in anteprima con START InSight una serie di studi, statistiche e approfondimenti (consultabili in versione inglese e italiana sul sito www.startinsight.eu).
Mentre i vari paesi si avviano verso una riapertura graduale, facciamo il punto sui dati di cui bisogna tenere conto e sui messaggi che devono passare.
L’INTERVISTA
La pandemia è stata caratterizzata da una continua produzione e diffusione di numeri, curve, previsioni. Quali sono i dati più affidabili, anche per capire la direzione in cui andare adesso?
Durante eventi come questo è molto difficile, per non dire impossibile, produrre delle stime o delle previsioni che siano assolutamente valide ed incontrovertibili. È naturale ed aggiungerei legittimo essere critici sui numeri. La situazione è estremamente fluida. I dati di riferimento cambiano continuamente e ci sono problemi relativi alla loro effettiva qualità. Parlo ad esempio dei cosiddetti soggetti asintomatici non identificati, per i quali provvedere una stima precisa è francamente impossibile, a meno di ricorrere a test di massa. Il problema è dovuto anche ai criteri diagnostici, che sono cambiati nel tempo, o a quelli utilizzati per dichiarare una morte come causata dal coronavirus anziché come avvenuta indipendentemente da esso in un soggetto infetto. Sembrano questioni semplici, ma non lo sono. Soprattutto perché non abbiamo ancora dei criteri universali. Ad esempio, quando si cerca di stimare la mortalità della pandemia o, ancora più importante, di offrire previsioni sul suo sviluppo, la scarsa qualità dei dati a disposizione pesa parecchio. Partiamo dalla mortalità. Essa è variata nel tempo, ma sarebbe ingenuo pensare che ciò sia dovuto principalmente ad un cambiamento del virus dal punto di vista biologico. La variazione è quasi certamente dovuta ad aggiustamenti nel calcolo della percentuale di individui deceduti sui casi attivi rispetto ai diversi criteri utilizzati dagli statistici. Se ad esempio usiamo una finestra di 8 giorni dal manifestarsi dei sintomi al decesso, (per l’Italia) otteniamo una mortalità di circa lo 0.6%. Ma se consideriamo 10 giorni, la mortalità aumenta. Parliamo in fin dei conti di eventi che si protraggono nel tempo e seguono meccanismi non ancora del tutto chiari alla scienza; è dunque difficile offrire certezze. Per questo, per quanto le stime e le previsioni sull’andamento del contagio siano importanti -direi imprescindibili- al fine di pianificare le politiche sanitarie e sociali, esse non devono essere prese per oro colato. Al contrario, devono essere viste nel quadro di assunti e paradigmi che sono per loro stessa natura incompleti. La scienza opera, o almeno dovrebbe operare, in condizioni di incertezza. Essa rimane un processo di scoperta sempre provvisorio e mai definitivo. La politica d’altro canto dovrebbe servirsi degli esperti per adempiere al proprio ruolo: e cioè di prendere delle decisioni difficili in momenti di incertezza e assumersene la responsabilità. Per questo, ritengo sempre e comunque utile produrre modelli statistici e computazionali sull’andamento della pandemia, e della sua mortalità, ma bisogna capirsi bene su cosa rappresentino, quali siano i loro limiti, e sul come debbano essere utilizzati.
I dati più sicuri li avremo a crisi terminata, potenzialmente tra diversi anni. Oggi guarderei al dato, promettente, di una riduzione costante dei ricoveri ospedalieri ed in particolare di quelli in terapia intensiva che ad oggi rappresenta meno del 5% dei casi accertati. Sappiamo infatti che è lì che maggiormente si concentrano i casi di decesso (con una stima di mortalità tra il 60% e l’80% – globalmente) e la pressione sul sistema sanitario nazionale. È anche un dato estremamente utile per stimare le conseguenze di una necessaria riapertura dell’economia. Specialmente se lo si riuscisse ad usare per capire quali sono i soggetti più a rischio e dunque da monitorare attivamente e proteggere. La riapertura del paese deve avvenire in relativa sicurezza ed in tempi brevi, ed è impensabile aspettare un azzeramento del contagio o la distribuzione di un vaccino. Altrimenti il rischio è quello di trasferire la pressione dal sistema sanitario a quello economico in quella che è già definita come la più grande depressione dal 1929. A livello globale ciò risulterebbe in una crisi sociale senza precedenti e l’ingresso in una fase di estrema volatilità politica che produrrebbe conseguenze molto più pericolose dello stesso virus nell’ambito delle relazioni internazionali.
Ci sono stati errori nella comunicazione dei dati scientifici relativi al coronavirus?
Non penso che i dati siano errati, più precisamente erano e sono incompleti e di scarsa qualità come è naturale avvenga in frangenti di crisi. Certamente però vi sono stati errori di comunicazione. Oggi sappiamo che la pandemia è stata inizialmente sottovalutata, ma ultimamente mi sembra che si sia passati al fronte opposto e che la paranoia stia determinando le nostre scelte. Sarebbe facile accusare i media di questo. La politica ha le sue responsabilità, ma a mio avviso l’errore è principalmente negli scienziati. Spesso non siamo stati completamente onesti, o espliciti, e il messaggio che è passato è che le stime ed i modelli previsionali siano delle vere e proprie profezie. Pensiamo ad esempio come i modelli, provvisori ed estremamente limitati, elaborati dall’Imperial College di Londra siano stati usati come unico criterio di riferimento per le politiche pubbliche di molti paesi (v. nota in calce per la critica dettagliata del modello)[1].
Come ho premesso, ciò non è solo impossibile ma contrario al metodo scientifico. Oltretutto le previsioni odierne sembrano essere quasi sempre orientate al ‘worst case scenario’; a mio modo di vedere per non essere più accusati di sottovalutarne le conseguenze.
A pandemia inoltrata, come leggere quella che inizialmente era considerata l’anomalia Italia?
Non ritengo che l’Italia sia più da considerarsi un’anomalia. Senz’altro, almeno in una fase iniziale, il virus si è diffuso in modo estremamente veloce e con un livello di letalità inaspettato. E questo era certamente anomalo. E tuttavia da un lato abbiamo visto che, col passare del tempo, quasi tutti i paesi si stanno allineando tra di loro sia in termini di diffusione del contagio che di mortalità.
I dati indicano che il case fatality rate è stabilmente sotto l’1% dal 5 di aprile.
Ad oggi (16 aprile), il valore è dello 0.61% a 8 giorni dal manifestarsi dei sintomi (0.65% a 10 giorni). I dati relativi al fattore di crescita sono stabilmente sotto il valore di 1, e quindi indicano la decrescita del contagio, a partire dal 12 aprile (v. i dettagli nello studio pubblicato in precedenza a questo link).
Inoltre, i ricoverati in terapia intensiva sono in costante rapida diminuzione dal 4 aprile, mentre in generale i ricoveri sono in flessione dal 7 aprile.
D’altro lato, è certo che sappiamo ancora molto poco del virus e dei fattori che ne facilitano la diffusione. Gli studi che stanno emergendo in questi giorni, ad esempio, suggeriscono che non tanto l’età, quanto la presenza di condizioni croniche di salute come diabete, ipertensione e obesità, siano da ritenersi responsabili dei casi più gravi di infezione. Relativamente alla diffusione geografica, il dato che emerge sembra suggerire che questa avvenga più facilmente in aree altamente industrializzate e magari con scarsa attenzione alla qualità ambientale. Non sorprende dunque che i paesi più industrializzati, e al loro interno le aree maggiormente sviluppate come la pianura padana, la città di New York o la provincia di Wuhan, siano quelli più colpiti dal virus. Forse ciò accade per colpa di una popolazione molto più affetta da patologie preesistenti e già indebolita da fattori ambientali ma anche, come suggeriamo alla Chapman University in uno studio in via di pubblicazione, a causa della particolare struttura della popolazione e dei network sociali che è tipica delle aree più operose di un paese: cioè una popolazione attiva più giovane e dinamica, e un’importanza maggiore del tessuto di supporto sociale dato dalle relazioni intergenerazionali.
Come valuta il dialogo / scontro fra politica e ricercatori al tempo del COVID19?
Certamente la politica deve ascoltare la scienza prima di prendere delle decisioni, ma la scienza non può pensare di sostituirsi alla politica né assumere le caratteristiche di una religione infallibile. Personalmente ritengo che sia importante mantenere una distinzione chiara dei ruoli e che gli scienziati, in particolare, non cedano alla tentazione di fare i politici. Questo perché i politici sono soggetti al controllo democratico degli elettori; un principio fondamentale dell’ordinamento democratico. Mentre la scienza non opera, e non deve operare, in modo democratico. Leggo ad esempio, e con una certa preoccupazione, che alcuni esperti virologi vorrebbero creare una struttura permanente di monitoraggio sui rischi pandemici. Fin qui nulla di male; ben venga. Bisognerebbe anzi inquadrarla in una discussione complessiva sulla creazione di strutture di resilienza e difesa civile. Ma che la si voglia legalmente in grado di imporre misure di quarantena o limitazione dei diritti individuali è francamente inaccettabile in un paese democratico. Insomma se, come vorrebbero gli epidemiologi, il modello auspicato è quello della Corea non possiamo certo ispirarci a quella del Nord.
Come valuta l’impatto della pandemia sul futuro delle relazioni internazionali?
Sto leggendo diverse teorie sull’origine del virus. Mentre sembra ormai scontata un’origine naturale, vi sono sospetti che il suo rilascio possa dipendere da errori avvenuti in un laboratorio cinese dove il virus, come accade in molte altre nazioni, era studiato. Se fosse confermato che la Cina ha avuto delle responsabilità dirette sulla pandemia, in aggiunta alla sua gestione tardiva e poco trasparente del contagio, si profilerebbero scenari inquietanti per le relazioni internazionali. Ciò porterebbe infatti ad un inasprimento delle già difficili relazioni diplomatiche, e potenzialmente di quelle economiche, con il gigante asiatico che potrebbe reagire in modo molto aggressivo. Questo si aggiungerebbe alle già evidenti tendenze isolazioniste americane e alla possibile implosione dell’Unione Europea, sempre più disarmonica, che già esce con le ossa rotte dalla pandemia. Uno scenario del genere getterebbe non poche ombre sulla già precaria governance mondiale e minerebbe di fatto importanti progetti comuni sul fronte dei cambiamenti climatici e dei processi di pace oggi in atto in diverse aree del pianeta.
[1] Il modello è quello che più di tutti ha informato le strategie di contenimento dell’infezione; in particolare l’idea di “flatten the curve”; è molto sofisticato ma si basa su assunti che derivano da informazioni imperfette. Ad esempio, il valore di R0 che il modello assume, il numero di riproduzione di base, ovvero il numero medio di nuovi casi per ogni persona infetta, e’ stabilito a priori su circa 2 individui. In altre parole, il modello assume che ogni individuo infetto tende ad infettarne altri due, ma questa non è una misura reale della sua infettività. Va da sé che anche una minima differenza tra il dato assunto e quello effettivo si amplifica in eccesso o difetto quando viene estesa a livello nazionale. Inoltre, per fare un altro esempio, i ricercatori hanno usato un periodo di incubazione di cinque giorni e hanno ipotizzato che la trasmissione abbia inizio 12 ore prima dell’inizio dei sintomi. Altra cosa che, col tempo, abbiamo scoperto non essere vera. La lista è lunga: i ricercatori hanno anche assunto che la percentuale di casi ospedalizzati, cioè quelli che avrebbero richiesto strutture di terapia intensiva si aggirava attorno al 30% dei ricoverati mentre il dato è molto minore, o che il tasso di mortalità dei pazienti in terapia infettiva fosse del 50%, che gli anziani fossero i più colpiti, ecc. Venendo al punto, i valori utilizzati come assunti del modello si basano sulle informazioni che i ricercatori avevano all’epoca dell’elaborazione del modello e pertanto i suoi risultati sono da considerarsi molto limitati. Gli stessi ricercatori, ovviamente, non hanno fatto segreto di queste limitazioni ma spesso i nostri giornali ed esperti televisivi le hanno omesse. Un’altra cosa che il modello ha offerto è una stima della popolazione degli infetti non identificati; che veniva stimata attorno a 6 milioni di individui ed è stata riportata da tutti i quotidiani ed esperti. Quello che tuttavia è stato spesso omesso, è che lo stesso modello riportava come intervallo di confidenza, e cioè un insieme di valori che con una certa “confidenza” contiene il valore vero, andava dai circa 2 ai quasi 16 milioni di individui. Insomma, non esattamente la stima puntuale che si voleva far passare. Ciò è esemplificativo dell’uso spregiudicato che si è fatto dei modelli.
Cause di morte per COVID19: non è l’età, ma la combinazione di alcune malattie (Chapman University)
di Steven Gjerstad e Andrea Molle – Chapman University, USA
Lo suggerisce uno studio della Chapman University statunitense, pubblicato in anteprima esclusiva da START InSight.
“È un risultato estremamente importante, non solo perché permette di valutare meglio i pazienti di COVID-19 in fase di triage. Nelle fasi successive, a partire dalla cosiddetta fase 2 fino alla produzione e distribuzione di un vaccino, sarà fondamentale prendere delle decisioni mirate a proteggere prima di tutto la parte della popolazione più esposta a gravi conseguenze. Prima del vaccino, gli individui affetti da ipertensione, diabete, malattie cardiache, se non già immuni, dovranno necessariamente essere tenuti sotto stretto controllo. Non solo in quanto soggetti a rischio, ma soprattutto perché rappresentano il primo vero campanello di allarme di una eventuale risurgenza del contagio. Sappiamo infatti che sono questi individui a presentare i sintomi più severi mentre i soggetti sani possono essere del tutto asintomatici e dunque diffondere silenziosamente il virus.”
LA RICERCA
Malattie cardiache, ipertensione, diabete, ictus e malattie del fegato: identificare la presenza di questi fattori in fase di triage aumenta la possibilità di sopravvivenza.
La reazione globale all’epidemia di COVID-19 si basa sul presupposto critico che tutte le persone di età superiore ai 60 anni affrontano un inaccettabile rischio di morte se infettate dal virus. Un’analisi dettagliata dei dati dei singoli pazienti cinesi, americani e italiani indica invece chiaramente che questa ipotesi non è corretta. La nostra ricerca prova che solo lo 0,8% di tutti i decessi correlati al coronavirus in Italia riguarda individui altrimenti sani. Il restante 99,2% dei decessi riguarda individui che avevano almeno uno, e spesso almeno altri tre, fattori di malattia. Da questa scoperta derivano implicazioni significative in termini di politica sanitaria, e per le strategie di quarantena e di triage.
Statisticamente l’età non è il fattore determinante come causa di morte. Il decorso della malattia è identico tra pazienti anziani e giovani senza morbilità.
L’epidemia di coronavirus in Italia ha messo a dura prova le risorse ospedaliere, in particolare la disponibilità letti e ventilatori per la terapia intensiva dei pazienti che soffrono di insufficienza respiratoria acuta. I primi studi di comorbidità da COVID-19 effettuati in Cina [1], Italia [2] e Stati Uniti [3] suggeriscono che i tassi di mortalità aumentano rapidamente con l’età, in particolare oltre i 60 anni. Gli stessi studi mostrano anche che i decorsi nefasti aumentano sostanzialmente con la comorbilità fattori come malattie cardiache, ipertensione, diabete, ictus e malattie del fegato [1, 4]. È noto che questi fattori di morbilità aumentano rapidamente con l’età [5, 6]. Questa nota analizza in dettaglio l’ipotesi che l’età possa non essere un fattore indipendente che aumenta la mortalità COVID-19. Tra gli anziani la maggiore incidenza di malattie cardiache, diabete, ipertensione e altri fattori di comorbilità portano ad un aumento dell’incidenza di mortalità tra i pazienti più anziani con COVID-19. La distinzione è importante per guidare al meglio le decisioni di triage per ricoveri e terapia intensiva.
un triage più efficace aumenta le probabilità di sopravvivenza
Comprendere se sono i fattori di comorbidità che portano alla morte dei pazienti affetti da COVID-19, e non l’età, aiuterà a rendere il triage più efficace se le anche persone anziane sane riceveranno un trattamento, poiché le loro probabilità di sopravvivenza sono buone. I dati offerti dall’Istituto Suoperiore di Sanità (ISS) forniscono prove che in realtà sia la comorbidità a portare alla morte i pazienti di COVID-19.
I dati forniti dall’ISS possono essere usati per confermare che l’età da sola non porta alla morte per COVID-19. Il 48,5% dei casi fatali di COVID-19 in Italia fino al 17 marzo presentava 3 o più fattori di comorbilità. Un altro 25,6% aveva 2 di questi fattori e il 25,1% aveva un fattore. Solo lo 0,8% dei pazienti non soffriva di alcuna patologia. Quest’ultima statistica è importante. Se l’età da sola fosse un fattore indipendente che porta mortalità, allora ci aspetteremmo di vedere molti più decessi tra coloro che sono anziani ma altrimenti sani. In altre parole, siccome in Italia circa il 40% di tutti i casi di COVID-19 è rappresentato da persone di età superiore ai 70 anni, la frequenza senza fattori di comorbilità sarebbe molto più elevata dello 0,8%. Se anche un quarto di quelle persone fosse in buona salute e se gli anziani in buona salute fossero realmente ad alto rischio di decesso per COVID-19, stimiamo che almeno il 10% di tutti gli incidenti mortali causati da COVID-19 sarebbe tra riscontrarsi tra persone anziane con zero fattori di comorbilità. Ma sappiamo che solo lo 0,8% delle morti è tra persone anziane senza fattori di comorbilità.
l’età non è un fattore che porta alla mortalità per COVID-19
Da ciò concludiamo che l’età non è un fattore che porta alla mortalità per COVID-19. E’ evidente che i pazienti anziani senza comorbidità non muoiono di COVID-19 e quindi le decisioni di triage che risultano nella non ammissione in ospedale di questi soggetti non incrementano la mortalità di questo gruppo di età. È probabile che questi pazienti si riprendano, ma è anche probabile che si possano riprendere più rapidamente e con meno danni fisici ricevendo qualche forma di trattamento. È inoltre improbabile che richiedano un periodo di terapia intensiva molto più lungo di un giovane sano, poiché si stanno riprendendo in modo analogo ai giovani che non presentavano fattori di comorbilità.
gli anziani senza malattie pregresse si stanno riprendendo in modo analogo ai giovani
Se questo dato venisse recepito dalle strutture sanitarie, consentirebbe un turnover dei pazienti molto più rapido. Questo a sua volta potrebbe alleviare la pressione sull’infrastruttura sanitaria italiana. Per questi motivi, riteniamo che le decisioni sul triage debbano essere prese indipendentemente dall’età del paziente. Inoltre, se il dato venisse confermato da altri studi nazionali, una politica di quarantena più efficace potrebbe essere mirata solo alle persone identificate dai loro medici di base come a rischio.
Steven Gjerstad, Economic Science Institute, Chapman University, Orange, California, 92866 USA
Andrea Molle, Department of Political Science and Institute for the Study of Religion, Economics and Society, Chapman University, Orange, California, 92866 USA
[1] Wu, Zunyou and Jennifer M. McGoogan, “Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China,” Journal of the American Medical Association, Feb. 24, 2020.
[2] Livingston, Edward and Karen Bucher, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy,” Journal of the American Medical Association, March 17, 2020.
[3] “Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) — United States, February 12–March 16, 2020.” Centers for Disease Control, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 18 March 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e2
[4] “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia,” Instituto Superiore di Sanita, 17 Marzo 2020.
[5] “Age-adjusted percentages of selected circulatory diseases among adults,” Centers for Disease Control, Summary Health Statistics: National Health Interview Survey, 2018. https://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/NHIS/SHS/2018_SHS_Table_A-1.pdf
[6] “Diabetes prevalence and glycemic control among adults,” Centers for Disease Control, 2018. https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2015/040.pdf