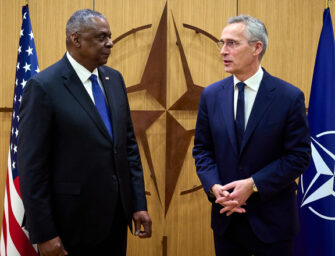START InSight con OtherMovie 2019
Radicalizzazione in carcere e ‘ISIS: una questione di famiglia’

venerdì 12 aprile ore 20.00 serata speciale OtherCrime
Franklin University Switzerland, Via Ponte Tresa 29, 6924 Sorengo
Nielsen Auditorium
a cura di Chiara Sulmoni, giornalista.
Il direttore di OtherMovie Drago Stevanovic e il professor Morris Mottale di Franklin University annunceranno la nuova collaborazione.
Il Califfato è caduto nel Levante ma il terrorismo di matrice jihadista continua a colpire in Occidente e in altre parti del mondo. Oltre alle incognite e agli interrogativi sul futuro dei foreign fighters, in Europa a preoccupare è anche la radicalizzazione interna che in parte passa dalle carceri, da sempre terreno fertile per gli estremismi di ogni genere. Ma qual è la situazione effettiva dietro le sbarre? Come nasce e come si diffonde il radicalismo nelle prigioni? Quali iniziative di prevenzione vengono messe in campo nelle due realtà vicine del Ticino e dell’Italia? E quali sono il ruolo e i punti di vista della politica e dei legislatori?
L’argomento verrà affrontato nel corso di un dibattito con il Consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni; Stefano Laffranchini, Direttore delle strutture carcerarie cantonali; Claudio Bertolotti, analista dell’ISPI e direttore di START InSight; Fra’ Ignazio De Francesco, monaco, islamologo, volontario in carcere. Modera Chiara Sulmoni.
Segue la proiezione del documentario:
Dustur di Marco Santarelli | Italia | 2016 | 74’ | vo italiano con sottotitoli in inglese.
Sinossi: Nella biblioteca del carcere di Bologna, un gruppo di detenuti musulmani partecipano a un corso organizzato da insegnanti e volontari sulla Costituzione italiana. Un giovane arabo in attesa del fine pena è alle prese con gli «inverni e le primavere» della libertà e un futuro tutto da scrivere. Un viaggio dentro e fuori il carcere, per raccontare l’illusione e la speranza di chi ha sognato e continua a sognare un «mondo più giusto».
All’interno del carcere si affrontano numerosi temi quali l’uguaglianza, la libertà, il diritto al lavoro e all’istruzione; all’esterno invece scorre la storia del giovane Samad, ex-detenuto marocchino che, in attesa della fine della pena, ottiene il permesso di partecipare agli incontri come libero cittadino. Samad insieme ai suoi ex-compagni proverà a stilare una nuova dustur, che tradotto in lingua araba, significa “costituzione”.
Premi: Cinema du Réel 2016: International Competition – The Youth Award; Italia in Doc – Bruxelles 2016: Concorso – Premio del Pubblico; Torino Film Festival 2015: Italiana.doc – Premio Avanti, Premio Gli Occhiali di Gandhi
sabato 13 aprile ore 20.15 LUX art house Via Motta 61, 6900 Massagno (Lugano)
sezione Culture e Conflitti
a cura di Chiara Sulmoni, giornalista.
Serata sul tema ‘ISIS: questione di famiglia’ con la proiezione del documentario “L’oblio delle macerie-Raqqa la capitale fantasma” di Filippo Rossi | Svizzera | 2019 | 12′. Con l’introduzione dell’autore rientrato di recente dal territorio siriano.
La discussione su ciò che resta del Califfato e in particolare sul rapporto tra famiglia, Stato Islamico e terrorismo jihadista continuerà insieme a Claudio Bertolotti, esperto di terrorismo di matrice jihadista, analista dell’ISPI (Milano) e direttore di START InSight (Lugano). Modera Chiara Sulmoni.
Ore 21.15 Of Fathers and Sons (Di padri e figli) di Talal Derki | Germania / Siria / Libano / Qatar | 2017 | 98’| vo arabo, sottotitoli in italiano 
Sinossi: Il regista siriano torna in patria fingendosi un fotoreporter filo-jihadista che realizza un documentario sull’ascesa del califfato nel contesto della guerra civile siriana. Il risultato è un ritratto crudo, e al tempo stesso intimo, della quotidianità del generale Abu Osama – un leader islamista radicale del gruppo armato al-Nusra – e dei suoi figli: uno sguardo inedito e inquietante sulla relazione padre figlio e sull’educazione salafita alla guerra santa.
Premi: Gran Premio della Giuria, Competizione Documentari del Mondo (Sundance Festival, 2018), Nominazione Oscar per Miglio documentario in lingua straniera 2019
Analisi dei flussi migratori nei Paesi del Maghreb. Le migrazioni di transito tra i Paesi dell’Area e nel Mediterraneo verso l’Europa
Sbarchi di #immigrati irregolari, “chiusura dei porti”, ruolo delle ONG, criminalità organizzata e business dei migranti, analisi e previsioni dei flussi migratori verso l’Italia e l’Europa.
Tutto questo nell’importante studio di Claudio Bertolotti – uscito oggi – sui flussi migratori verso l’Europa, prodotto per lo Stato Maggiore della Difesa e scaricabile gratuitamente
“Analisi dei flussi migratori nei Paesi del Maghreb. Le migrazioni di transito tra i Paesi dell’Area e nel Mediterraneo verso l’Europa” – Studio Ce.Mi.S.S.
Lo scopo di questo studio – commissionato dalla Sezione Cooperazione Balcani e Mediterraneo dell’Ufficio Relazioni Internazionali dello Stato Maggiore della Difesa – è l’approfondimento di una tematica che investe pienamente le realtà dei Paesi nord-africani, in particolar modo Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania e Libia – ma anche Niger e Ciad – e ne analizza caratteristiche, origini, rotte e le conseguenze su sicurezza, stabilità ed economia.
Il tema dei flussi migratori verso l’Europa e della loro gestione da parte degli Stati nazionali e dell’Unione Europea è un tema ampiamente dibattuto sul piano politico interno e internazionale ed ha importanti ripercussioni su quello sociale e della sicurezza, sia a livello di percezione che su quello reale.
La crescente pressione migratoria dal continente africano verso l’Europa e l’Italia ha condizionato i processi politici ed elettorali interni all’Europa portando alla ridefinizione degli equilibri nazionali e comunitari.
Tra i soggetti migranti che raggiungono l’Europa attraverso i flussi migratori irregolari, si riconoscono le due grandi categorie: quelli di tipo “economico”, che con la collaborazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) si tenta di rimpatriare nei Paesi di origine, ed i soggetti che fuggono da situazioni di guerra o conflittualità violenta, la cui protezione rappresenta la missione primaria dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
La prevalenza dei “migranti economici”, originari dell’Africa centrale, settentrionale e orientale e dell’area sub-sahariana, si contrappone alla componente minoritaria di soggetti di area mediorientale in fuga da zone di guerra.
Una delle rotte delle migrazioni extra-continente africano più calcate è quella che dai Paesi sub-sahariani attraversa il Nord Africa, in particolare la Libia, e il Mediterraneo; mentre una componente significativa di soggetti alimenta un flusso migratorio interno ai Paesi del Maghreb stesso.
All’interno dello studio, l’importante contributo di Filippo Rossi sui flussi migratori attraverso il Niger presentato in anteprima all’OtherMovie Film Festival di Lugano, diretto da Drago Stevanovic con la collaborazione di Chiara Sulmoni.
ISBN 978-88-99468-90-3
Scarica gratuitamente il volume
C. Bertolotti – Stato Islamico sconfitto sul campo in Siria ma l’ideologia è ancora viva (AGENSIR)
Dal sito di AGENSIR, 5 marzo 2019
Di seguito, potete leggere l’intervista di Daniele Rocchi al Direttore di START InSight Claudio Bertolotti, a margine della presa dell’ultima roccaforte dell’ISIS in Siria, a Baghuz.
“Sconfitto sul campo di battaglia ma non sul piano della mentalità e dell’ ideologia. Da questo versante la risposta non può essere solo militare ma anche e soprattutto politica”: così Claudio Bertolotti, analista strategico dell’Ispi, commenta al Sir la battaglia di Baghuz, l’ultima roccaforte dell’Isis in territorio siriano, poco distante dal confine iracheno. La guerra con l’Isis si vince anche con una proposta politica di lungo respiro che tenga in conto le attese delle popolazioni segnate dalla guerra.
Le forze arabo-curde, con l’appoggio dell’aviazione americana, fronteggiano gli ultimi jihadisti asserragliati in un fazzoletto di terra, ben poca cosa rispetto a un terzo della Siria e un terzo dell’Iraq che avevano conquistato nel 2014. Ad alzare la posta di una eventuale resa il destino di 24 ostaggi, compresi alcuni occidentali. Tra loro potrebbe esserci anche il gesuita padre Paolo Dall’Oglio, come alcuni media libanesi hanno rilanciato. “Siamo davanti ad un risultato importante sul campo di battaglia” – dice l’analista che è anche direttore di Start InSight” (www.startinsight.eu)- possiamo parlare di “sconfitta militare. Ma non è la fine della guerra. Lo Stato islamico va sconfitto anche come ideologia”.
L’Isis, infatti, aveva già messo in conto una sconfitta militare, e sin dal 2015, spiega Bertolotti, “ha adottato delle strategie di contrasto tornando ad essere una forza insurrezionale. Questo perché la comunità internazionale, con Siria e Iraq, non sono riusciti ad eliminare quelle cause sociali che lo hanno fatto emergere”. Chiaro il riferimento alle “divisioni interne, alla corruzione, all’instabilità politica, alla povertà, alla carenza di infrastrutture, servizi e di lavoro in questi due Paesi. L’esportazione della democrazia non ha prodotto risultati positivi da nessuna parte”.
L’Isis è stato sconfitto militarmente in Siria e in Iraq ma è ancora presente in Afghanistan, Mali, Filippine, Yemen, Sinai, Libia, Nigeria, Somalia. Una sorta di franchising del terrore, è così?
Lo Stato Islamico, con un approccio strategico di lungo respiro, ha capito che il suo futuro non avrebbe potuto essere territoriale o avere una forma statuale, ma avrebbe dovuto adattarsi alle dinamiche geopolitiche e ai tentativi di contrasto dell’Occidente e degli stessi Paesi arabi. A partire dal 2015 la strategia è stata quella di spingere i suoi potenziali miliziani a combattere nel territorio di residenza, in Europa o altrove, piuttosto che recarsi in Siria o Iraq. Al tempo stesso, avvalendosi di gruppi storicamente già consolidati come Boko Haram in Nigeria, si è passati ad una sorta di franchising in cui lo Stato islamico ha concesso il suo brand di successo in cambio della fedeltà al Califfo. Conflitti locali innestati dentro un contesto di guerra e di jihad globale. Ma Isis ha altri canali di diffusione ideologica come il web, il rientro dei reduci e combattenti dal fronte siro-iracheno nei loro Paesi di origine o il trasferimento degli stessi in Paesi terzi per continuare a combattere.
La guerra contro l’Isis che si combatte sul fronte dell’ideologia è decisamente più difficile da sradicare. Più che militare, servirebbe una risposta politica…
Il rischio che si corre è quello di commettere lo stesso errore fatto in Iraq, o in qualche modo che si sta commettendo anche in Afghanistan: quello di dare alla componente militare il peso maggiore in una strategia che deve essere anche politica. Un paese non può essere abbandonato dopo l’abbattimento di un regime terribile come quello dello Stato Islamico.
Occorre pensare ad una strategia di lungo respiro che lavori sul piano politico, che preveda il coinvolgimento di tutte le componenti nazionali e che risponda concretamente alle esigenze della popolazione locale in ambito di sicurezza, stabilità, infrastrutture, istruzione, lavoro, necessarie non a sopravvivere ma a vivere con dignità.
Chi potrebbe dare questa risposta politica? Anche quei Paesi dell’area che in un passato recente hanno mostrato di avere rapporti non troppo limpidi con lo Stato Islamico?
Se ci riferiamo a Paesi come l’Arabia o il Qatar, io credo che, da un lato, ci sia la presa di coscienza di un esperimento sfuggito di mano con risultati noti a tutti. Il supporto all’Isis non è mai avvenuto per canali ufficiali ma attraverso fondi, associazioni e fondazioni caritatevoli che in qualche modo hanno fatto giungere fondi allo Stato Islamico che poi ha attivato una serie di commerci di petrolio, beni archeologici, di sfruttamento dei flussi migratori arrivando a interagire con gruppi criminali collegati a terroristi. Si tratta di Paesi che hanno giocato non ufficialmente la carta di gruppo destabilizzante per potersi, una volta limitato l’Isis, avvantaggiare su eventuali tavoli negoziali con l’Occidente o con altri Paesi dell’area. Basti pensare alla conflittualità esistente tra Arabia saudita e Iran, alla presenza diretta di attori iraniani in Siria che hanno combattuto contro l’Isis o all’approccio da guerra di prossimità (proxy war) adottato dall’Arabia Saudita sostenendo gruppi islamisti tra cui l’Isis.
Il passaggio dello Stato islamico ha lasciato sul terreno non solo morti e distruzioni ma anche popolazioni divise, frammentate al loro interno. Da una parte chi ha sostenuto l’Isis e dall’altra chi lo ha combattuto o peggio subito, come le minoranze yazide, cristiane, mandee. Sarà possibile ricostruire i legami antichi di un tempo?
Il tessuto sociale in Siria e in Iraq è devastato. La contrapposizione tra sciiti e sunniti ha portato in Siria alla sostanziale sparizione di intere popolazioni che hanno abbandonato il Paese. Nel frattempo attraverso anche piani di investimento immobiliare l’Iran sta acquisendo ampie aree siriane precedentemente abitate da sunniti per ripopolarle con popolazioni sciite. Così facendo si modificano equilibri che hanno retto per almeno 100 anni, dagli accordi di Sykes-Picot (1906) che hanno regolato i confini degli Stati mediorientali dividendo intere tribù e famiglie. L’equilibrio di Sykes-Picot oggi è venuto meno. Il successo dello Stato islamico è quello di aver abbattuto anche fisicamente quei confini e il sistema sociale che ne derivava. Ripristinare un tale equilibrio è impossibile. I vuoti si riempiono velocemente ma i trasferimenti di popolazioni portano a nuovi conflitti. Il rischio è vedere altre contrapposizioni tra sciiti e sunniti impegnati a portare avanti i propri progetti di natura politica nascondendoli sotto il mantello della religione.
Il tutto a danno delle minoranze etnico-religiose o di quel che resta di queste che non possono vantare particolari aiuti, se non quello dell’Occidente…
Se l’Occidente vuole avere un ruolo nel futuro del Medio Oriente deve sostenere le popolazioni locali anche senza presenza diretta. Il ruolo dell’Occidente è proteggere – si tratta di un principio delle Nazioni Unite – le minoranze, quelle che hanno patito in questi anni di guerra le violenze peggiori. Pensiamo a yazidi e cristiani che hanno in gran parte abbandonato le loro terre in Siria e Iraq.
Altro problema posto dalla sconfitta militare dell’Isis è quello dei foreign fighters catturati e che dovrebbero essere rimpatriati. Molti governi occidentali sono riluttanti a riprenderli poiché sarebbe legalmente difficile formulare accuse e istruire processi, con il rischio di doverli rilasciare. Come gestire questo dossier?
I foreign fighters sono oggi la minaccia principale che va aggiunta a quella dei radicalizzati già presenti all’interno degli Stati. I foreign fighters di ritorno europei sono circa 4 mila. Si stima possano esserne rimasti in vita circa 2400, 800 quelli in mani siriane, irachene e curde e in attesa di processo. Il rientro dei foreign fighters è stato confermato anche dalla nostra intelligence pochi giorni fa in Parlamento.
Si parla di soggetti che stanno facendo ritorno, alcuni di questi – pochi in verità – anche attraverso i flussi migratori irregolari. Questo rappresenta un fattore di criticità. I soggetti che sono ancora in Siria, Iraq e in Nord Africa potrebbero rientrare o recarsi in Paesi terzi a combattere. Lo abbiamo già visto in Libia, in Afghanistan e nel Sud Est asiatico.
Come affrontare nello specifico il caso degli 800 foreign fighters detenuti di nazionalità europea o occidentale?
Si tratta di un aspetto molto preoccupante al punto da spingere i governi europei a non prendere una decisione. Farlo potrebbe significare, da un lato, esporsi alle critiche dell’opinione pubblica, e dall’altro, trovarsi a gestire un problema difficile sul piano del diritto. La situazione più comoda – come dimostra la Gran Bretagna – è togliere la nazionalità ai propri cittadini e lasciare che vengano processati nel paese dove sono stati arrestati. Vale anche per l’Italia che ha tra i suoi 138 foreign fighters diversi detenuti nelle carceri curde. Non prendere una decisione può in parte risolvere o spostare in avanti il problema.
Tutti si chiedono che fine abbia fatto il Califfo al Baghdadi…
Negli ultimi due anni si sono registrate diverse notizie che, a vario titolo, davano al Baghdadi catturato o braccato. L’ultima risale a poche settimane fa. C’è chi vocifera che possa essere dentro una delle ultime sacche di resistenza. Detto questo credo si possa dire che se non si troverà vivo o almeno il corpo, in caso fosse deceduto, si verrà a realizzare il suo disegno strategico: scomparire fisicamente per essere sempre presente così come è stato per il Mullah Omar in Afghanistan, prima che si confermasse la sua morte. Indipendentemente dalla morte fisica, ciò che conta, per i suoi adepti, è la sua sopravvivenza ideale e ideologica.
Afghanistan: cosa manca all’accordo tra USA e talebani? (ISPI)
Articolo originale pubblicato per ISPI, Scarica il Pdf del commentary ISPI
 A un mese dal primo incontro preliminare con l’inviato statunitense per il processo di pace Zalmay Khalilzad, dal 25 al 27 febbraio e poi ancora sabato 2 marzo 2019 i talebani hanno riaperto le porte del loro ufficio politico di Doha, la capitale del Qatar. Il quinto dell’ultima serie di incontri avviati dagli Stati Uniti e dai talebani nell’estate del 2018, ma che hanno escluso il governo afghano.
A un mese dal primo incontro preliminare con l’inviato statunitense per il processo di pace Zalmay Khalilzad, dal 25 al 27 febbraio e poi ancora sabato 2 marzo 2019 i talebani hanno riaperto le porte del loro ufficio politico di Doha, la capitale del Qatar. Il quinto dell’ultima serie di incontri avviati dagli Stati Uniti e dai talebani nell’estate del 2018, ma che hanno escluso il governo afghano.
I colloqui di Doha sono stati i più importanti, tra i molti avvenuti durante tutta la guerra, sia per il livello delle delegazioni, sia per i risultati in termini di convergenza di intenti, benché con tempi e modalità differenti. Colloqui che però, a fronte delle aspettative, non hanno portato a un accordo condiviso: «Finora non vi è stata convergenza su alcun accordo o documento» ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, il 3 marzo. Dunque, tutto rinviato ai prossimi incontri.
L’argomento cardine dell’incontro è stato il “ritiro completo” delle truppe straniere dall’Afghanistan, conditio sine qua non imposta dai talebani per l’avvio di qualunque soluzione negoziale; da parte statunitense è stata posta la volontà di proseguire la lotta al terrorismo, più per ragioni di opinione pubblica interna – propensa a sostenere il ritiro ma non a una soluzione che renda vani i sacrifici fatti. In merito all’ipotesi di ritiro delle truppe straniere entro un limite temporale da tre o cinque anni, discussa a febbraio dagli Stati Uniti con i paesi europei, i talebani hanno precisato che tali tempistiche non sono esito dell’accordo tra le due parti.
Che qualcosa sui tavoli di Doha si stesse muovendo si era capito già il precedente 25 gennaio, quando il capo dei talebani, il mawlawì Hibatullah Akhundzada, aveva nominato il mullah Abdul Ghani Baradar – fino ad allora e per 8 anni detenuto in Pakistan – a capo della commissione politica per il negoziato con gli Stati Uniti: uno dei più esperti tra i comandanti e acuto stratega politico, è forse la figura più influente tra i vertici talebani. Un cambio al vertice che ha avuto lo scopo di lanciare un preciso messaggio: è la leadership del movimento che si siede al tavolo negoziale la cui regia è nelle mani di un altro importante e storico rappresentante talebano, Sher Mohammad Abbas Stanakzai. Una scelta che è al tempo stesso un chiaro indicatore della mediazione tra Stati Uniti e Pakistan, e il ruolo di quest’ultimo nel processo negoziale.
Chi ha preso parte ai negoziati?
La delegazione statunitense guidata da Zalmay Khalilzad era composta da 15 funzionari, tra i quali il generale Austin S. Miller, comandante delle forze militari straniere in Afghanistan. In apertura dell’incontro, Khalilzad ha evidenziato la necessità di dare al negoziato tempi dilatati ed ha manifestato la volontà di definire una road map per l’Afghanistan – sebbene la priorità sia la salvaguardia degli interessi e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Obiettivi primari rispetto all’ambizione di dare al governo afghano un ruolo nel futuro del Paese.
Il mullah Baradar, investito dei pieni poteri decisionali e gestionali, ha guidato la delegazione talebana di 14 membri[1]. Il mullah Mohammad Anas Haqqani, figlio del defunto mujaheddin Jalaluddin Haqqani e fratello minore di Sirajuddin, leader della rete Haqqani e braccio destro del leader talebano, è stato l’unico membro del consiglio politico a non poter partecipare ai colloqui in quanto detenuto in Afghanistan; per lui già a gennaio il movimento talebano aveva avanzato richiesta di rilascio.
I temi discussi
Queste le tematiche affrontate nella tre giorni di Doha: ritiro totale delle forze militari straniere secondo un calendario concordato, impegno da parte talebana ad impedire che l’Afghanistan possa ospitare gruppi terroristi, come lo Stato Islamico o al-Qa’ida, in grado di minacciare la sicurezza statunitense e degli alleati, scambio di prigionieri e cancellazione dalle black list del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dei vertici talebani impossibilitati a viaggiare. Infine, altri due importanti temi affrontati sono stati la possibilità di un “cessate il fuoco” e la partecipazione al negoziato del governo afghano che i talebani considerano un “fantoccio”: un elemento rilevante è la possibile rinuncia da parte talebana ad annunciare la consueta “offensiva di primavera”.
Ruolo e diritti delle donne non sono invece nell’elenco dei temi oggetto di negoziato, né lo saranno.
Mortificato il governo di Kabul: escluso dal tavolo negoziale
Pur escluso dai negoziati, il governo di Kabul insiste nella ricerca del più ampio sostegno possibile da parte dei gruppi di potere e delle istituzioni tradizionali; in tale ottica il Presidente Ashraf Ghani ha convocato per marzo una Loya Jirga, l’assemblea dei leader politici e tribali, per concordare la posizione negoziale del governo nei colloqui con i talebani. Kabul teme che Washington possa negoziare un ritiro improvviso, ma è anche vero che l’inclusione in un secondo momento è oggetto di negoziazione da cui i talebani trarranno ulteriore vantaggio. Apprezzato in maniera trasversale il ruolo dell’ex presidente dell’Afghanistan Hamid Karzai.
L’opzione statunitense rifiutata dai talebani
L’opzione del ritiro, sostenuta dagli Stati Uniti, si basa sul disimpegno di 7.500 militari statunitensi entro il primo semestre 2019 e dei restanti 7.000 entro 3 o 5 anni, con un impiego esclusivamente di tipo contro-terrorismo che non includa i talebani tra i target: in linea con il limite temporale del 2024, sancito sulla base degli accordi bilaterali del 2014 che garantiscono l’utilizzo delle basi strategiche da parte statunitense.
La Nato (17.000 unità a marzo 2019) rimarrebbe in Afghanistan almeno fino al 2020 con una forza residua a supporto delle forze di sicurezza afghane. Infine vi è la questione dei contractor e delle compagnie di sicurezza private: al momento 25.239 operatori, destinati ad aumentare.
Riguardo alle conseguenze, il dimezzamento delle unità militari straniere e il parallelo taglio delle risorse destinate allo sviluppo e al mantenimento delle forze di sicurezza afghane – che dipendono al 90 percento dall’aiuto economico statunitense e della Comunità internazionale – lascia prevedere un probabile collasso dell’apparato di sicurezza nazionale e il probabile passaggio di molti militari e poliziotti nei ranghi delle milizie personali dei signori della guerra o della droga o degli stessi gruppi di opposizione armata. Uno scenario che aprirà a una ulteriore situazione di caos, alimentato da nuove dinamiche competitive e conflittualità tradizionali tra gruppi di potere, gruppi tribali e attori regionali.
Le incognite in sospeso
L’incognita principale è la rappresentatività: la delegazione a Doha ha parlato a nome di tutte le anime del movimento talebano o solamente della componente più vicina alla leadership? Il rischio è che le componenti più radicali e più giovani possano andare a rafforzare i ranghi dei gruppi che combattono il jihad globale, come al-Qa’ida e lo Stato islamico-Khorasan.
Preoccupa la sempre più massiccia presenza di jihadisti stranieri: l’Afghanistan sta vivendo l’effetto boomerang del jihadismo di ritorno. Nel Paese si sono riversati miliziani reduci della guerra in Siria: oltre agli afghani, anche uzbeki, uiguri, ceceni, arabi ed europei che non possono tornare nel vecchio continente.
Influisce, infine, la capacità talebana di muoversi con tempi molto dilatati e su più tavoli negoziali: con la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Così facendo hanno indebolito e diviso il fronte internazionale, togliendo agli Stati Uniti il monopolio del negoziato.
[1] Tra questi, mawlawì Ziaur Rahman Madani, mawlawì Abdus Salam Hanafi, sheikh Shahabuddin Dilawar, mullah Abdul Lateef Mansoor, mullah Abdul Manan Omari, fratello minore del fondatore dei talebani, il mullah Mohammad Omar, mawlawì Ameer Khan Muttaqi, mullah Mohammad Fazil Mazloom, mullah Khairullah Khairkhwa, mullah Noorullah Noori, mawlawì Mohammad Nabi Omari e mullah Abdul Haq Waseeq.