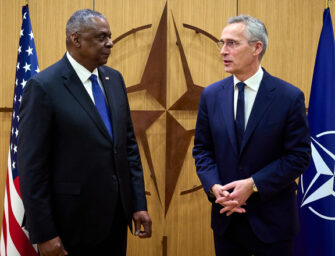De-radicalizzazione e studi sul cervello degli estremisti jihadisti nella puntata del programma ‘Laser’ (Radio svizzera di lingua italiana)
Di cosa si occupano e cosa implicano i programmi di de-radicalizzazione?
E come reagisce il cervello di un sostenitore di gruppi jihadisti, in determinate situazioni? Cosa ci raccontano le scansioni cerebrali?
Cosa può intensificare la radicalizzazione e cosa favorisce invece il distacco e il disimpegno dalla violenza?
spesso gli individui, quando vengono allontanati dall’ISIS o da al-Qaeda o da altri orientamenti jihadisti, si trovano nella condizione di non appartenere più a nessuno. La loro identità è spezzata, non corrisponde più a quella del combattente in guerra contro il mondo. Anche il rapporto con la moralità è reciso, perché la loro prospettiva precedente, che era bianca o nera, è andata in frantumi. Non hanno più, necessariamente, un senso della moralità. Ognuna di queste cose deve essere sostituita da un’altra. Devono essere reintegrati. (Rashad Ali)
ASCOLTA ‘DERADICALIZZAZIONE. DENTRO LA MENTE JIHADISTA’
Nella puntata del programma Laser (RSI) andato in onda martedì 22 settembre 2020, Chiara Sulmoni ne ha parlato con Rashad Ali (Institute for Strategic Dialogue, Londra), impegnato nei progetti di contrasto al radicalismo sia nelle prigioni, che nell’ambito della libertà vigilata e della società più in generale; e con Nafees Hamid, ricercatore e psicologo della radicalizzazione (Artis International e International Centre for Counter-Terrorism), che racconta i risultati delle sue indagini sul terreno in Spagna, volte a capire cosa avviene nel cervello di un sostenitore di movimenti jihadisti; con delle conclusioni importanti, per capire anche le difficoltà legate al processo di disimpegno dalla violenza. Questi risultati, convalidati scientificamente dalle scansioni cerebrali, sottolineano e confermano il ruolo centrale dell’esclusione sociale come fattore importante nel processo di radicalizzazione, e rispettivamente dell’influenza e della pressione sociale nel riportare l’individuo a ‘ragionare’, grazie alla riattivazione di aree del cervello che si erano in precedenza spente.
Oltre alle questioni trattate nel documentario di approfondimento, riportiamo un’ulteriore affermazione di Nafees Hamid:
“Tendiamo a concentrarci troppo sul singolo soggetto, sul modo di sviluppare le capacità personali, il pensiero critico, per prevenire la radicalizzazione. Il problema è che mentre la radicalizzazione si manifesta a livello individuale, le sue origini si trovano dentro la comunità. Per questo vediamo una distribuzione geografica caratterizzata da focolai che attecchiscono in quartieri specifici, da cui proviene il grosso delle reclute -vale per tutti i gruppi terroristici, non solo jihadisti-. Si tratta in genere di comunità vulnerabili, dove mancano coesione sociale, senso di identità, di appartenenza, obiettivi da realizzare.
molti sono attratti dai gruppi terroristici perché invitano a battersi per una causa, ti danno qualcosa da fare. Se vogliamo fare prevenzione, non basta buttare lì dei bei messaggi, o creare delle relazioni fra un soggetto e un mentore
Invece di soffermarci tutto questo tempo sulle facoltà individuali e sui messaggi alternativi, dovremmo impegnarci maggiormente nel contrastare il coinvolgimento. Molti sono attratti dai gruppi terroristici perché invitano a battersi per una causa, ti danno qualcosa da fare, una ragione per alzarti dal divano -puoi diventare un foreign fighter, un trafficante, un predicatore, puoi promuovere il movimento, puoi fare delle cose, con la tua vita-. Dovremmo trovare il modo di offrire un’alternativa concreta. Se vogliamo fare prevenzione, non basta buttare lì dei bei messaggi, o creare delle relazioni fra un soggetto e un mentore. Se questa esigenza primaria di essere agenti di cambiamento sociale viene soddisfatta all’interno delle comunità, che sia attraverso i centri sociali, le scuole o altri luoghi dove trovare uno scopo -non un semplice mestiere, o una fonte di reddito, parlo di un vero scopo- allora offri alle persone un motivo per non rivolgersi ai gruppi estremisti.”
La direzione delle normative anti-terrorismo in Europa. Ne discutiamo con il giurista Francesco Rossi
Il terrorismo in Europa rimane una minaccia concreta. Al di là degli attentati riusciti, lo dimostrano i numerosi piani sventati, le reti estremiste regolarmente scompaginate dalle forze di sicurezza, la propaganda online che tiene costantemente impegnati in una guerra senza quartiere partner pubblici e privati nel campo della tecnologia e per finire, anche alcuni recenti casi di recidiva -un aspetto, quest’ultimo, su cui si sta concentrando la ricerca specialistica nel tentativo di definire meglio i contorni del rischio per gli anni a venire-.
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, due brutali attacchi portati a termine da jihadisti passati per il carcere in Gran Bretagna, hanno dato avvio a un dibattito attorno alla durata della reclusione. Una prima, urgente stretta legislativa ha annullato la procedura di rilascio automatico a metà della pena. In seguito, ha preso avvio l’iter parlamentare per l’approvazione di una nuova legge anti-terrorismo più severa che, per quelli che saranno considerati i reati più gravi, prevede fra l’altro condanne più lunghe, da scontare per intero e un monitoraggio dopo la scarcerazione che può arrivare a 25 anni. Anche in altri paesi come la Francia e la Svizzera sono attualmente in discussione e in dirittura d’arrivo misure più restrittive, che in prima bozza hanno anche suscitato le critiche e la preoccupazione di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, Amnesty International o la stessa UE.
Per approfondire la questione e fornire un ritratto più preciso del panorama giuridico europeo, START InSight ha posto alcune domande a Francesco Rossi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, membro di MacroCrimes (Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità) e a breve ricercatore post-doc presso la Faculty of Law, Economy and Finance dell’Università di Lussemburgo.
- Dr. Rossi, le polemiche e le discussioni accese che seguono ogni attentato in Europa, sembrano dipingere uno scenario in cui l’apparato legislativo sarebbe in costante ritardo rispetto alla realtà della minaccia terroristica; qual è la posizione del giurista al riguardo?
Il giurista è tradizionalmente critico al riguardo. Beninteso: ineccepibilmente, contrastare il terrorismo costituisce una priorità assoluta di un numero sempre più alto di governi. Tuttavia, non può destare stupore che in una democrazia – che deve rispettare le “regole del gioco” fissate dalle Carte e dalle Corti dei diritti – la legislazione evolva più lentamente di un fenomeno criminale organizzato e pronto a reagire a ogni intervento repressivo.
Grazie anche a programmi di analisi del fenomeno ben sviluppati, chi legifera è tendenzialmente a conoscenza dei tratti essenziali del terrorismo che stiamo contrastando. I problemi risiedono altrove: non è l’attenzione, bensì l’approccio a suscitare le critiche degli addetti ai lavori. Dopo pressoché ogni attentato, tutte le forze politiche finiscono per convergere sull’introduzione di nuovi reati, sull’aumento delle pene, sulla previsione di regole processuali derogatorie, sul potenziamento delle misure amministrative “di corredo” allo strumentario penale. I sistemi penali vengono sempre più sovraccaricati, senza però creare un reale valore aggiunto in ottica preventiva. Anziché aspirare a riportare terroristi attuali e potenziali dalla nostra parte, la strategia antiterrorismo diffusa in Europa persegue piuttosto gli obiettivi di neutralizzarli e sorvegliarli il più a lungo possibile, preferibilmente in carcere.
non può destare stupore che in una democrazia la legislazione evolva più lentamente di un fenomeno criminale organizzato e pronto a reagire a ogni intervento repressivo
Vi è comunque un’altra ragione. Dalla prospettiva politica, volenti o nolenti, legiferare rapidamente e rigidamente nel vivo dell’emergenza è razionale perché coagula il consenso elettorale. In una fase storica in cui il populismo è così forte, questa circostanza non favorisce affatto un dibattito lucido sul contenuto delle leggi antiterrorismo. Anzi…
- Tendenzialmente, le leggi che abbiamo oggi nei vari paesi quanto sono efficaci e commisurate alla situazione che viviamo?
Scientificamente, non esistono criteri che consentano di valutare univocamente, senza possibilità di replica, l’efficacia e la proporzionalità delle misure antiterrorismo. Certo, i contributi accademici umanistici forniscono le coordinate culturali imprescindibili per comprendere a fondo il fenomeno. Inoltre, le analisi statistiche in materia aumentano e vengono progressivamente affinate.
Sulla base di questo background è possibile sviluppare riflessioni eterogenee. Molto brevemente, le possibili prese di posizione sul modo in cui contrastare il terrorismo sono fondamentalmente inquadrabili in tre linee di pensiero. La prima postula che il terrorismo debba essere sconfitto senza violare o derogare alcuna norma della Costituzione e delle Carte sovranazionali dei diritti. La seconda, diametralmente opposta, accosta il contrasto al terrorismo a una guerra e legittima persino l’annichilimento delle norme di garanzia. La terza, mediana, sostiene che si debba individuare quali deroghe alle regole del gioco siano costituzionalmente sostenibili e al tempo stesso utili a contrastare il terrorismo.
Nel mondo accademico, la prima linea di pensiero è decisamente prevalente. Tuttavia, una precisazione si impone. Le leggi antiterrorismo vigenti sono senza dubbio utili ed efficaci per le autorità preposte alla protezione della sicurezza collettiva, che possono intervenire ben prima che un individuo radicalizzato passi all’azione: tendenzialmente, nella pratica, prima che intraprendano un viaggio con finalità di terrorismo o quando dichiarano, online o ad altri soggetti, di essere risoluti a passare all’azione. Le stesse leggi consentono altresì di monitorare con attenzione i reclutatori e i facilitatori, dediti rispettivamente ad assicurarsi la disponibilità all’azione di individui radicalizzati e a rendere materialmente possibile la concretizzazione futura dei loro propositi terroristici. Gli interventi delle autorità in questione sono evidentemente preziosi: senza di loro, il numero di attentati realizzati in Europa sarebbe più alto.
le leggi antiterrorismo vigenti sono senza dubbio utili ed efficaci per le autorità preposte alla protezione della sicurezza collettiva, che possono intervenire ben prima che un individuo radicalizzato passi all’azione
Tuttavia, le leggi antiterrorismo vigenti non risultano affatto risolutive. Esse non incidono affatto sulle cause della radicalizzazione e del terrorismo: consentono soltanto di intervenire sui focolai già emersi. Dunque, il risultato che questa modalità di intervento può produrre non è macro-, ma micro-preventivo.
Inoltre, al risultato micro-preventivo lordo (determinato dalla quantità di interventi restrittivi cautelari e irrevocabili effettuati) vanno sottratti gli effetti collaterali che gli attuali eccessi di incriminazione possono produrre. A medio-lungo termine, in un contesto in cui si tende tuttora ad associare – acriticamente, a volte in maniera discriminatoria – terrorismo e Islam, la scelta di anticipare all’estremo l’intervento repressivo rischia persino di rivelarsi in parte criminogena. Punire, apertamente o sotto mentite spoglie, la sola radicalizzazione del singolo musulmano stigmatizza un fenomeno interiore sì aberrante e potenzialmente pericoloso, ma che costituisce comunque una pura e semplice ideologia.
Questo è un lusso che il sistema penale non può permettersi: storicamente, non serve il terrorismo per comprendere l’essenza contro-democratica del punire pensieri in luogo di fatti… Le potenziali ricadute del ricorso alla pena in questo settore devono essere stimate alla luce di molteplici fattori. In breve, più l’incriminazione risulta sproporzionata, maggiore sarà il numero di soggetti borderline – simpatizzanti non violenti, per varie ragioni vulnerabili alla presa ideologica della galassia “jihadista” – che potrebbero finire nel vortice della radicalizzazione e, nel peggiore dei casi, del terrorismo.
Il vero risultato micro-preventivo netto si deve dunque determinare considerando anche queste ipotesi; comprese quelle della radicalizzazione in carcere, causata sia a monte da scelte incriminatrici non del tutto razionali, sia a valle da strategie e modalità di esecuzione della pena detentiva inadeguate. Non solo in Italia, persino i contesti familiari, affettivi e di aggregazione come i centri culturali –soprattutto prima che ne aumentasse la sorveglianza – si sono spesso tramutati in focolai di radicalizzazione. In casi simili, provate a pensare cosa potrebbe implicare il ricorso a una punizione stigmatizzante ed esemplare, non seriamente improntata a un reinserimento sociale e nemmeno preceduta da un diverso sforzo di natura non coercitiva. Di fronte a un fenomeno che fermenta in contesti geopolitici, sociali, culturali ed economici torbidi, condizionati da decenni di conflitti, discriminazioni e ingiustizie, questo tipo di punizione dissuaderebbe le persone vicine al condannato o rischierebbe piuttosto di rafforzare in loro un’ideologia antagonista, incline alla violenza terroristica?
Ad alcuni tale osservazione apparirà provocatoria, o persino un affronto. Essa dovrà però essere presa in seria considerazione, se si intende razionalizzare ed innovare le strategie di contrasto al terrorismo.
- Le preoccupazioni che possono essere espresse dagli organismi internazionali nei confronti di alcune misure repressive o anticipatorie, sono giustificate di fronte al pericolo rappresentato dal terrorismo?
La risposta può variare a seconda delle misure di volta in volta analizzate. Adottare un approccio mediano nella valutazione delle misure antiterrorismo consentirebbe di discernere quali di esse siano per certi versi difficili da digerire, ma per altri versi necessarie o comunque utili, e quali invece risultino più “costose” che benefiche o persino manifestamente inefficaci e incostituzionali.
È comunque bene sottolineare che un numero sempre crescente delle misure adottate in Europa negli ultimi anni non supera il “test di necessità”. Un esempio: a volte criticato dalla dottrina d’oltralpe per la sua tendenziale ritrosia in materia, il Conseil constitutionnel (la Corte costituzionale francese) ha dichiarato illegittime le norme antiterrorismo più controverse (tra cui quella che sanzionava penalmente la mera consultazione abituale di siti web a contenuto terroristico).
è bene sottolineare che un numero sempre crescente delle misure adottate in Europa negli ultimi anni non supera il “test di necessità”
Non possono e non devono essere puniti puri indici di adesione psicologica a ideologie senza che sia stata commessa alcuna azione tangibilmente pericolosa. Pronunce pur ancora sporadiche come quelle del Conseil constitutionnel possono rappresentare un modello di riferimento per le Corti degli altri Stati, attente sempre più spesso alle mosse delle colleghe europee per trarne potenziali spunti argomentativi.
- In un suo saggio del 2017, mette in rilievo come i sistemi penali nazionali tendano ad essere più rigidi -sia in senso preventivo che repressivo- rispetto alle fonti sovranazionali. Cosa ne consegue, e qual è l’impatto concreto sulla lotta al terrorismo?
Ne consegue una catena di interventi circolari che si consolidano e rafforzano reciprocamente. Spesso la dottrina addossa alle organizzazioni sovranazionali le fette maggiori di responsabilità per la scarsa chiarezza delle disposizioni, la carente pericolosità dei fatti sanzionati e la sproporzione delle pene irrogate. Ci si limita spesso a constatare che quando un’organizzazione sovranazionale interviene attraverso convenzioni internazionali, risoluzioni, decisioni quadro, direttive, gli Stati sono obbligati ad adattare la legislazione nazionale. La realtà è però più complessa. Radiografando i molti atti normativi che si sono succeduti tra le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Unione europea e gli Stati del Vecchio Continente, ci si accorge che questi ultimi hanno spesso anticipato – e persino ecceduto – molti degli interventi sovranazionali di cui stiamo parlando. Più precisamente: dall’11 settembre in poi, gli Stati europei più preparati e “quotati” nel settore del contrasto al terrorismo (Italia, Francia, Spagna e Regno Unito) hanno esportato in più occasioni i propri modelli politico-criminali, legislativi e pratico-applicativi. Finora, in questo ambito, le riforme penali sovranazionali hanno sempre avuto referenze in uno o più Stati, le cui legislazioni sono state più che altro “sintetizzate” per poterle adattare a ordinamenti che si rivolgono a Paesi numerosi e diversi tra loro.
A pressoché ogni attentato realizzato in uno Stato segue ivi una riforma penale, via via sempre più rigida. Lo Stato colpito interviene per primo e più duramente, mentre altri Paesi osservano le mosse altrui e le prendono in considerazione come possibili modelli da emulare. A questo punto, le agende antiterrorismo delle istituzioni sovranazionali si infittiscono e i modelli nazionali vengono elaborati fino a estrarne un nucleo condiviso in seno a ciascuna organizzazione (Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, Unione europea).
a pressoché ogni attentato realizzato in uno Stato segue ivi una riforma penale, via via sempre più rigida
Questo nucleo condiviso di previsioni penali antiterrorismo viene irradiato negli Stati ancora illesi dal terrorismo. Fuori dall’emergenza, questi ultimi – che non avevano varato riforme settoriali incisive – vengono trainati legislativamente dalle organizzazioni sovranazionali. Come si è visto, però, l’input politico e contenutistico proviene da quelle mosse nazionali cui si è fatto riferimento poc’anzi.
Dunque, almeno in prima approssimazione, il diritto penale antiterrorismo in Europa si sta armonizzando. Tuttavia, se questo modello di diritto penale è inadeguato, lo saranno anche tutte le sue varie declinazioni nei singoli Stati europei, e le rispettive controindicazioni potrebbero disseminarsi su tutto il Vecchio Continente.
- Quali sono i ruoli, i rapporti e anche i limiti che intercorrono fra le legislazioni nazionali e internazionali (UN, Unione Europea)?
Le legislazioni nazionali e le normative sovranazionali possiedono caratteristiche diverse. In breve, mentre le legislazioni nazionali fissano precetti e sanzioni penali applicabili nel territorio dello Stato e rivolti direttamente ai consociati, le normative sovranazionali fissano standard comuni per gli Stati ai quali le normative stesse si rivolgono (i Paesi aderenti a una convenzione internazionale, i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri dell’Unione europea e così via).
Le normative sovranazionali servono principalmente ad armonizzare (o ravvicinare) le legislazioni nazionali entro un contesto geografico più vasto rispetto a quello del singolo Stato. Sebbene nessuna fonte normativa sovranazionale possa mai dirsi identica a un’altra, l’armonizzazione delle legislazioni nazionali è favorita dalla vincolatività delle normative sovranazionali.
le normative sovranazionali servono principalmente ad armonizzare le legislazioni nazionali entro un contesto geografico più vasto rispetto a quello del singolo Stato
Sempre sintetizzando e semplificando, dall’ottica dei singoli Stati tale vincolatività si arresta soltanto di fronte a una violazione della Costituzione da parte della normativa sovranazionale. In ogni caso, l’armonizzazione delle legislazioni nazionali indotta dalle fonti sovranazionali vincolanti è affiancata dai flussi spontanei tra i modelli normativi dei Paesi europei. Simili flussi risultano fisiologici nell’era del pluralismo, dell’apertura, della globalizzazione giuridica e della trans-nazionalizzazione del crimine in cui viviamo.
- I paesi terzi come la Svizzera, dal profilo giuridico, come si posizionano dentro il ‘panorama’ UE della lotta al terrorismo?
Pur con tutti i particolarismi derivanti dai mutevoli contesti storici, sociali e politici di volta in volta considerati, il terrorismo è un fenomeno transnazionale che necessita strategie di contrasto condivise su larga scala, capaci di facilitare quantomeno la cooperazione giudiziaria tra Stati diversi. Questa consapevolezza favorisce forme di incontro spontaneo tra istituzioni e autorità dei vari Paesi. A tal fine, tramite la designazione e l’operato di rappresentanti politici e magistrati di collegamento nazionali, l’Unione europea rappresenta anche per gli Stati terzi un punto di riferimento ideale per un confronto politico, legislativo e pratico-applicativo costruttivo, volto soprattutto a condividere informazioni, linee d’azione e migliori prassi.
- I foreign fighters di rientro dalla Siria porrebbero davvero dei problemi di difficile soluzione ai sistemi penali/giudiziari nazionali/europei, come sostiene chi è contrario al rimpatrio?
Attualmente, sì. I carichi di lavoro per gli stakeholders della sicurezza aumenterebbero, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire, ad esempio, in termini di dispendio di risorse umane ed economiche, di esigenze di aggiornamento professionale e di disponibilità e formazione di personale specializzato.
Il discorso muta, invece, riguardo alla possibilità delle Procure di sottoporre con successo a procedimento penale un numero consistente di returnees. Il problema principale è di ordine probatorio: una volta lasciato uno Stato europeo per recarsi sui teatri del conflitto, solo l’intelligence riesce (non sempre, e incontrando svariati ostacoli) a reperire informazioni utili sui foreign fighters. Inoltre, alcune testimonianze recentemente raccolte sul campo hanno fotografato un’altra rilevantissima problematica: per cause di natura non solo giuridica – attinenti essenzialmente alle discrepanze legislative e alla questione dei diritti umani – ma anche politica, il tentativo di cooperare con le autorità degli Stati (mediorientali, africani e via dicendo) in prima linea nella guerra al terrorismo si rivela spesso una strada a fondo chiuso.
rimpatriare foreign fighters di ritorno solleva timori per la sicurezza pubblica e può mettere in bilico persino la maggioranza al governo
Anche in questo caso, comunque, ogni responsabilità da mancato rimpatrio è imputabile anche agli Stati europei, che si dimostrano particolarmente recalcitranti anche di fronte alle vicende drammatiche che vedono coinvolti donne e bambini. La ragione è fondamentalmente duplice: rimpatriare foreign fighters di ritorno solleva timori per la sicurezza pubblica e può mettere in bilico persino la maggioranza al governo. Le recenti vicende politiche in Norvegia, dove nel gennaio 2020 il partito della destra populista ha infranto l’accordo che li legava alla coalizione di governo in reazione alla decisione di rimpatriare dalla Siria una donna sospettata di aver preso parte alle atrocità dello Stato Islamico, sono emblematiche in questo senso. Una tra le possibili alternative – lo svolgimento di processi penali nei confronti dei membri dello Stato Islamico in Siria – rappresenta forse una tentazione per molti Stati europei; anche se, mentre toglierebbe all’Europa alcune castagne dal fuoco, questa soluzione non porrebbe certo rimedio alle violazioni dei diritti umani diffuse in quelle aree.
- Le leggi attuali e le riforme in corso secondo lei possono rispondere bene alle necessità e ai requisiti della prevenzione e della deradicalizzazione? Ci sono criticità da affrontare?
il mondo penalistico denuncia da tempo l’inadeguatezza dei programmi di de-radicalizzazione in carcere, dal quale molti escono ancor più de-socializzati
Le criticità sono numerose. Oggi, una larghissima parte del carico preventivo è scaricato sulla sorveglianza e sulla giustizia penale. Invece, il quadro relativo alla prevenzione extra-penale della radicalizzazione in Europa è ancora molto frammentato. È evidente, ad esempio, il ritardo legislativo dell’Italia su questo fronte (mentre proseguono, fortunatamente, alcune sperimentazioni progettuali virtuose, concertate da accademici e operatori professionali). Inoltre, il mondo penalistico denuncia da tempo l’inadeguatezza dei programmi di deradicalizzazione in carcere, dal quale molti escono ancor più de-socializzati. Sono disponibili esempi anche recenti in questo senso: soprattutto nel Regno Unito e in Francia, dove lo stigma derivante dalla condanna per reati terroristici – che comprendono anche mere manifestazioni ideologiche sì aberranti, ma di per sé innocue – si protrae anche a pena espiata, mediante l’applicazione misure di sicurezza marcatamente restrittive.
non è stata ancora raggiunta una sufficiente uniformità di vedute, ad esempio, sui limiti etici e sugli obiettivi concreti che i programmi di prevenzione e de-radicalizzazione devono porsi
Investire maggiori risorse sulla prevenzione extra-penale della radicalizzazione e sui programmi di de-radicalizzazione in carcere si rivela cruciale per perfezionare strategie di contrasto, a lungo termine e a più ampio raggio, alla radicalizzazione e al terrorismo. Tuttavia, lo stato dell’arte in materia è non solo frammentato, ma anche per certi aspetti controverso. Non è stata ancora raggiunta una sufficiente uniformità di vedute, ad esempio, sui limiti etici e sugli obiettivi concreti che i programmi di prevenzione e de-radicalizzazione devono porsi. Inoltre, uno studio recente ha evidenziato uno scarto ancora da colmare tra gli apporti accademici e le reali esigenze degli operatori professionali sul campo. Non si può negare, dunque, che la strada sia ancora particolarmente lunga e insidiosa.
GUERRA E PACE NEL MEDITERRANEO: capire l’escalation turca tra l’espansionismo cinese e il riassetto degli equilibri mediorientali
di Andrea Molle
La rinnovata importanza del Mediterraneo, spesso ritenuto un teatro secondario nell’ambito dell’analisi delle Relazioni Internazionali, deriva da diversi processi di medio e lungo periodo che oggi scuotono gli equilibri geopolitici mondiali. In particolare, è la conseguenza dell’aggressiva politica commerciale cinese in Africa Subsahariana, intensificatasi nell’ultimo decennio, che vede gli stati africani, come ad esempio il Kenya e il Congo, ridotti a colonie oppure in una situazione di subordinazione de facto agli interessi del Gigante Asiatico.
A questa dinamica fa eco la volontà di Beijin di completare il progetto della Belt and Road Initiative, imponendosi come partner commerciale privilegiato delle principali potenze europee nel tentativo di creare un rapporto non di sudditanza, ma certamente di forte dipendenza, per l’Unione Europea. Ciò è reso possibile, in primo luogo, dal vuoto lasciato dalla deriva protezionista ed isolazionista dell’America guidata da Donald J. Trump che sembra priva di una strategia internazionale, ma anche dall’assenza di una direzione comune europea in politica estera come dimostra il recente smarcamento dell’Italia in favore della Cina.
L’intensificarsi dei flussi migratori, aggravati anche dai mutamenti climatici, dalla corruzione e dalla presenza di processi di radicalizzazione nel continente africano, è il sintomo più evidente della destabilizzazione, politica ed economica, risultante dalla politica espansionista cinese che ha consegnato al governo di Beijin il controllo di importanti rotte e hub commerciali. A fronte di una sostanziale erosione del tessuto economico, causata dal monopolio attuato dagli operatori economici cinesi, e dell’instaurarsi di drammatici squilibri sociali, sempre più persone abbandonano il loro paese e cercano fortuna in Europa accentuando così la crisi del continente. L’alleggerirsi della pressione demografica contribuisce, paradossalmente, a perpetuare il controllo cinese sui governi africani ed accuire la crisi e le divisioni all’interno dell’Unione Europea.
La situazione è infine acuita dall’insieme delle recenti iniziative messe in campo dalla Turchia al fine di conquistare un ruolo egemonico nel Maghreb e nel Mediterraneo orientale, apparentemente facilitato dalla comune cultura islamica di cui il paese si propone come difensore in competizione con paesi come l’Arabia Saudita, ma che è soprattutto una conseguenza del ritiro americano e dell’assenza di una voce unica europea. Nell’attesa delle dimissioni previste a fine ottobre di Fayez al-Sarraj, fino ad oggi alla guida del Governo di Accordo Nazionale (GNA) riconosciuto dalle Nazioni Unite, resta da capire quali saranno le conseguenze sulle attività Turche in Libia, ma rimane inalterata la volontà di Ankara di farsi avanti come principale interlocutore cinese approfittando della particolare congiuntura politica.
Per comprenderne meglio la strategia e non sottovalutarne le probabilità di successo, è importante considerare l’insieme delle relazioni sino-turche. I segnali in questo senso sono molteplici. Un ammorbidimento delle politiche dei visti tra le due potenze è in corso da anni e, in aggiunta agli intensificati scambi culturali, la Cina ha recentemente provveduto a trasferire ingenti risorse economiche destinate a supportare i piani di sviluppo industriale e soprattutto militare del governo guidato da Erdogan. Per venire meno alla sua strutturale inadeguatezza militare, pare che la Turchia stia oggi valutando l’acquisto di velivoli da combattimento stealth di quinta generazione Shenyang J-31. Si tratta di una conseguenza diretta dell’esclusione dal progetto Lockheed Martin F-35 voluta dagli USA, ma rappresenta un passo ulteriore verso l’uscita della Turchia dalla NATO. Qualora dovesse avvenire, la perdita del partner turco provocherebbe di certo una crisi dell’Alleanza Altantica che già per molti osservatori internazionali è in uno stato di animazione sospesa. Un eventuale indebolimento della NATO piace molto anche alla Russia di Putin che, nonostante le aperte tensioni geopolitche con la Turchia, fornisce già al paese sistemi antiaerei e spinge per l’acquisto dei caccia stealth Sukhoi Su-57.
In questo quadro non deve sorprendere la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e alcune delle medie potenze mediorientali come gli Emirati Arabi e il Baharain, e soprattutto le voci non confermate di possibili futuri accordi per lo sviluppo di assetti militari comuni. Questo processo non può essere considerato il mero risultato dell’azione politica di Trump per portare stabilità in Medio Oriente, a detta di molti insufficiente se non di fatto inestistente. Deve invece essere interpretata come un segnale di conferma di come il mondo arabo, in crisi per la futura inevitabile perdita di rilevanza, è consapevole dei profondi cambiamenti degli equilibri geopolitici del Mediterraneo orientale e sta cercando di guadagnare la posizione più vantaggiosa. Quello che si sta formando può apparire come un fronte anti-Turco, ma a ben vedere è più probabilmente un tentativo di opporsi alle mire neocoloniali cinesi in Africa o quantomeno contenerle, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dall’Occidente.
La partita con il Gigante Asiatico vede dunque oggi coinvolti quei paesi del Golfo, una volta nemici dello Stato Ebraico, che oggi pensano ad Israele come alleato naturale. D’altronde Tel Aviv rappresenta non solo un forte partner militare, ma anche un polo economico e tecnologico in grado di rivaleggiare con Beijin. Ciò auspicabilmente potrebbe portare anche ad una soluzione duratura al lungo conflitto Israelo-palestinese. Tale risultato non sarà però dovuto all’azione mediatrice americana ne agli sforzi congiunti di diversi paesi e organismi internazionali degli ultimi decenni, ma piuttosto alla presenza di un comune nemico all’orizzonte. Se una soluzione verrà dunque raggiunta, essa sarà a discapito degli interessi dei palestinesi che, ancorati a retoriche ormai desuete e sempre più marginalizzati dagli alleati di un tempo, non sembrano intenzionati a recepire il cambiamento ed adattare di conseguenza sia i loro obiettivi di lungo periodo che la loro strategia politica.
Se le tensioni con la Cina sono in aumento, di fronte all’aggressività turca gli Stati Uniti hanno alzato la voce solo di recente, provocando il temporaneo ritiro della missione esplorativa di Ankara nelle acque territoriali controllate da Atene, ma senza segnalare alcuna volontà esplicita di coninvolgimento americano nel teatro operativo. Si è trattato insomma di un atto dovuto che arriva, come si dice in America, “too late and one dollar short”. In risposta alla mossa americana e all’annuncio dell’intensificarsi delle esercitazioni delle forze armate greche nell’Egeo settentrionale la Turchia ha nuovamente accusato la Grecia di violare il Trattato di Losanna del 1923, che ha posto fine all guerra greco-turca (1919-1923) ridisegnando le nuove frontiere tra i due paesi, militarizzando l’isola di Chio. Non si tratta della prima volta che la Turchia accusa la Grecia di violare il Trattato. La prima volta è stata nel Giugno 1964, a seguito del dispiegamento di una brigata motorizzata ellenica sull’isola, ma questa volta la Turchia sembra non escludere una reazione militare alle esercitazioni annunciate da Atene.
Sulla sponda Nord del mare nostrum le cose non vanno certo meglio. Sebbene sia palese che la partita che si sta giocando nel Mediterraneo, e che vede coinvolti Grecia e Cipro, abbia come posta in gioco la sopravvivenza stessa degli interessi europei e occidentali, per non dire anche la tenuta della stessa Unione Europea, sono in pochi ad averlo pienamente compreso. Nelle capitali europee, il mutamento degli equilibri che per anni hanno accompagnato la politica mediterranea dell’Unione sembrano essere compresi solo a Parigi. Accusata di voler unicamente acquisire il controllo di marginali risorse energetiche, la seconda potenza dell’Unione Europea preme da sempre per un ruolo più incisivo dell’Europa e per la sua oggi imprescindibile integrazione militare. Questo mentre Berlino ragiona ancora troppo spesso come un trading state, interessato unicamente ai guadagni economici di breve periodo e a non turbare il precario equilibrio raggiunto con la Turchia sul tema dei migranti provenienti dalla rotta balcanica.
Quanto all’Italia, Roma pensa ingenuamente di poter ancora attuare la stessa politica dell’equidistanza e della neutralità che l’ha ridotta negli anni al ruolo di mera comparsa sulla scena degli affari internazionali e sul versante cinese ha una posizione per lo meno ambigua. E tuttavia la Francia, che appare come il candidato naturale a guidare la politica estera dell’Unione, non può pensare di riuscire a vincere questa partita da sola. La geografia non è un’opinione: senza l’Italia, che tra l’altro è la seconda potenza navale del continente, l’Unione Europea non ha nessuna possibilità di contare qualcosa e finirà, inevitabilmente, per essere relegata ad una umiliante posizione di sudditanza.
Operazione EUNAVFORMED “Irini”: limiti e criticità
di Claudio Bertolotti
Il vertice di Berlino come premessa all’operazione “Irini”
I partecipanti alla conferenza di Berlino sulla Libia del 19 gennaio 2020 si sono impegnati a rispettare e attuare pienamente l’embargo sulle armi istituito dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) e 2473 (2019). In tale contesto, il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per l’avvio di una nuova operazione nel Mediterraneo, finalizzata all’attuazione dell’embargo delle armi delle Nazioni Unite sulla Libia utilizzando risorse aeree, satellitari e marittime. Dopo mesi di negoziati la Grecia ha confermato l’assistenza a tutti i migranti irregolari sbarcati dalle navi militari dell’Unione Europea; questione che aveva di fatto bloccato qualunque iniziativa concreta. Questo significa, almeno formalmente, che non dovrebbero giungere in Italia i migranti irregolari eventualmente assistiti dalle navi impegnate nell’operazione.
Il 31 marzo 2020, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha così annunciato l’accordo sulla creazione dell’operazione militare EUNAVFOR MED “Irini”: missione a guida italiana, con il proprio centro operativo confermato a Roma.
la missione prevede ispezioni a navi in alto mare al largo della costa libica che siano sospettate di trasportare armi o equipaggiamenti militari
Oltre alla missione principale di sostegno all’attuazione dell’embargo sulle armi dell’ONU in Libia, la missione prevede ispezioni a navi in alto mare al largo della costa libica che siano sospettate di trasportare armi o equipaggiamenti militari conformemente alla risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Irini” ha ereditato alcuni compiti secondari dall’operazione “Sophia”, tra cui l’addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche e i compiti di ricerca e salvataggio.
Ma “Irini”, finalizzata all’attuazione di un embargo sulle armi, non ha sinora raggiunto l’obiettivo primario e questo a causa di una debolezza politica di fondo, dovuta all’eterogeneità delle priorità date dai singoli paesi dell’unione Europea, a cui si somma una limitata capacità militare.
Obiettivi dell’operazione “Irini”
Il 31 marzo 2020, il Consiglio dell’Unione europea ha formalmente dato il via all’operazione militare della UE nel Mediterraneo EUNAVFOR MED “Irini” (in greco “pace”) per contribuire alla realizzazione dell’embargo di armi sulla Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi così come sanzionato dalle Nazioni Unite. L’Unione europea, intenta ad intensificare gli sforzi per far rispettare l’embargo, intende contribuire in tal modo al processo di pace in Libia, attraverso l’avvio di una nuova operazione militare nell’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) nel Mediterraneo.
contrasto al traffico di esseri umani e distruzione delle reti criminali ad esso associate
L’operazione ha come fine principale l’attuazione dell’embargo anche attraverso la capacità di ispezione di navi dirette per e dalla Libia, dove vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tali mezzi trasportino materiale direttamente o indirettamente utile alle parti in conflitto, in violazione dell’embargo; ma l’ampia azione di “Irini” prevede la raccolta di informazioni quanto più estese ed approfondite sul traffico di armi ed equipaggiamenti militari, in alto mare al largo delle coste della Libia. Inoltre, come compiti secondari, EUNAVFOR MED “Irini” svolge attività di:
– monitoraggio e raccolta di informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati:
– contributo al rafforzamento delle capacità e alla formazione della Guardia costiera libica e della Marina militare nelle attività di contrasto in mare di traffici illeciti;
– contributo al contrasto del business derivante dal traffico di esseri umani e alla distruzione delle reti criminali ad esso associate attraverso il pattugliamento aereo e navale e la raccolta di informazioni;
Il mandato dell’operazione è esteso al 31 marzo 2021 ed è sotto stretto controllo degli Stati membri dell’UE che ne esercitano il controllo politico e la direzione strategica attraverso il Comitato politico e di sicurezza (PSC), sotto la responsabilità del Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’attuale operazione è spostata a Est rispetto alla precedente, “Sophia”: non più nel Canale di Sicilia, ma nelle acque tra Egitto e Creta con gli occhi puntati sulla Cirenaica.
Una situazione in progressivo peggioramento: le armi continuano ad arrivare in Libia
A seguito della trasformazione del conflitto libico, che da guerra civile si è trasformato in una “guerra per procura”, i rifornimenti militari di equipaggiamenti tecnologicamente avanzati hanno continuato ad arrivare in Libia via aerea, terrestre e marittima. Il fatto che gruppi armati non statali siano addestrati all’utilizzo di tali equipaggiamenti e sistemi d’arma è una pericolosa premessa non solo per il paese, ma anche per i paesi confinanti con la Libia: tra il 2012 e il 2014, terroristi e gruppi separatisti hanno integrato i loro arsenali con le armi provenienti dai magazzini delle disciolte forze armate libiche; ora tali armi potrebbero essere trasferite nei paesi vicini, alcuni dei quali sono sempre più alle prese con i violenti fenomeni insurrezionali che vedono, tra gli attori attivi e più pericolosi, il cosiddetto Stato islamico (IS) e al-Qa’ida.
l’embargo sulle armi riaffermato alla Conferenza di Berlino è stato violato da molti dei paesi che hanno preso parte al vertice
In tale scenario, l’ottimismo manifestato in occasione della Conferenza di Berlino appare come del tutto ingiustificato. La conferma giunge direttamente dalle Nazioni Unite: l’embargo sulle armi riaffermato alla Conferenza di Berlino è stato da allora violato da molti degli stessi paesi che hanno preso parte al vertice; molti aerei sono atterrati negli aeroporti della Libia occidentale e orientale, trasferendo armi, veicoli blindati, combattenti stranieri e “consiglieri militari”. Come riportato dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) “molti di coloro che hanno partecipato alla Conferenza di Berlino” erano stati coinvolti nel “trasferimento in corso di combattenti stranieri, armi, munizioni e sistemi avanzati” e altre attrezzature militari (Kaim, Schulz, 2020).
Dalla teoria alla pratica: difficoltà operative e limiti politici
Dal 4 maggio la missione dell’Unione Europea EUNAVFORMED “Irini” ha iniziato le attività in mare nella propria area di operazione ma, nonostante l’ottimismo con cui la missione ha preso il via, le differenti visioni dei paesi europei hanno imposto fin da subito limiti evidenti: le navi greca (“Spetsai”, classe “Hydra”) e francese (“Jean Bart”, classe “Cassard”) si sono unite all’operazione alla fine di maggio, mentre Malta, che aveva promesso personale imbarcato appositamente addestrato per la missione, ha successivamente ritirato la propria partecipazione in quello che può essere letto come un apparente tentativo di influenzare il Governo di Accordo Nazionale di Tripoli (GNA) e la Turchia.
Uno schieramento ridotto nelle risorse, sottodimensionato nelle capacità e debole
Alle fregate greca e francese e a un piccolo aereo da ricognizione marittima messo a disposizione da Lussemburgo e Polonia, insieme all’aereo da pattugliamento marittimo P-3C “Orion” tedesco, a luglio si è unita la nave italiana “San Giorgio” e, ad agosto, la tedesca “Hamburg” – una fregata classe “Sachsen” – con a bordo 250 militari; da parte italiana sono resi disponibili inoltre un drone per operazioni di sorveglianza, e le basi logistiche di Augusta, Pantelleria e Sigonella. Inoltre, un aereo P72 da pattugliamento marittimo, un velivolo per l’air early warning (Aew), e un sottomarino “saranno disponibili occasionalmente in supporto”. Uno schieramento che, sebbene il comandante dell’operazione abbia definito “presto capace di raggiungere la piena capacità operativa” (Pioppi, 2020), è di fatto molto ridotto nelle risorse, sottodimensionato nelle capacità rispetto agli obiettivi e reso debole dalla scarsa coesione politica dei 27 partner europei.
La sfida militare della Turchia all’Unione Europea
Il 10 giugno 2020, la fregata greca “Spetsai”, sotto comando italiano e impegnata nel tentativo di controllare il mercantile “Cirkin”, partito dalla Turchia e sospettato di trasportare armi a Tripoli, è stata contrastata nel golfo di Sirte dall’intervento diretto di un’unità militare di Ankara, impegnata nella scorta dello stesso mercantile (Hassad, 2020). Una seconda unità militare turca avrebbe inoltre avviato una manovra di avvicinamento alla fregata di Atene dopo il sorvolo da parte di un elicottero greco del “Cirkin”. L’evento si sarebbe concluso con l’azione turca di inquadramento radar della nave greca: premessa alla minaccia di apertura del fuoco che ha imposto alla “Spetsai” di ritirarsi.
Il mercantile “Cirkin”, battente bandiera della Tanzania, poi giunto senza rallentamenti nel porto di Tripoli l’11 giugno (il giorno successivo all’incidente), risulta essere partito dal Mar di Marmara, a sud di Istanbul, dopo essere stato attraccato in un porto “roll-on roll-off” (RORO) per un carico di armi, equipaggiamenti e mezzi pesanti, compresi veicoli corazzati trasferiti dalla vicina base militare dell’esercito turco. Il mercantile, varato nel 1980, con una lunghezza di 100 metri e un carico massimo di 4.000 tonnellate, è di fatto un cargo turco, già utilizzato in precedenza da Ankara per il trasporto di veicoli corazzati ed equipaggiamenti destinati al GNA.
L’incidente conferma i limiti politici e operativi dell’operazione europea
L’evento, che ha anticipato un analogo fatto che ha visto coinvolta la nave francese (anch’essa “minacciata” da una nave turca), è stato denunciato dalla Grecia come violazione dell’embargo delle Nazioni Unite, mentre la risposta turca ha evidenziato che essendo la “Cirkin” sotto la protezione della Turchia non era necessario l’intervento dell’operazione “Irini”. La Turchia, che ha di fatto messo a nudo le criticità dell’operazione europea nel Mediterraneo e ne ha denunciato la “faziosità e l’unilateralità a favore del generale Khalifa Haftar”, ha suggerito la creazione di un nuovo meccanismo da parte delle Nazioni Unite.
L’incidente, che solo in Grecia ha ottenuto un’ampia eco mediatica, è una conferma dei limiti politici, prima ancora che operativi, dell’operazione “europea e del suo obiettivo di imporre un embargo militare in Libia che, di fatto, al momento non è efficace lungo le rotte navali e non perseguito sui rifornimenti di armi ed equipaggiamenti che giungono alla fazione guidata dal generale Haftar via terra dall’Egitto e via aerea dalla Russia.
I due punti deboli di “Irini”
Il fatto che l’operazione “Irini” sia impegnata prevalentemente nell’attività di contrasto navale alle violazioni dell’embargo solleva interrogativi sulla sua reale efficacia. Due i punti di ingresso in Libia per gli aiuti militari alle due fazioni: il confine marittimo occidentale, che la Turchia ha usato per inviare armi, equipaggiamenti e combattenti al GNA, e il confine orientale, usato dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti per sostenere l’Esercito Nazionale libico (LNA) guidato da Haftar. Se l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti intendono trarre vantaggio dalla situazione, la Turchia non ha altra scelta che rifornire Tripoli di armi via mare, attraverso l’area che l’UE si è impegnata a controllare.
Nel merito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha lamentato che “la missione dell’UE non ha fatto nulla per fermare le spedizioni di altre potenze in Libia”, incluse “le armi che sarebbero state inviate dalla Francia ad Haftar”. Per contro, la Francia, che nega il supporto di Haftar ma è da tempo sospettata di favorirlo, ha espresso rabbia dopo che lo scorso 17 giugno la fregata “Courbet” è stata oggetto di “inquadramento radar” da parte delle fregate turche durante l’ispezione di un mercantile diretto in Libia.
Dell’operazione europea ha parlato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, evidenziando cosa essa non è e cosa non può fare: “Non si tratta di un blocco navale. Il quadro normativo internazionale include il blocco navale tra i metodi di guerra. Quindi, il blocco rappresenta una misura adottabile solo nel corso di conflitti armati internazionali. “Irini” prevede esclusivamente misure selettive, legittime e pienamente rispettose del diritto internazionale, finalizzate a promuovere il ritorno della pace e della sicurezza in Libia” (di Feo, 2020). Un’affermazione, quella del ministro degli esteri italiano, che conferma implicitamente i limiti strutturali di un’operazione che nasce con due criticità per l’imposizione di un effettivo embargo sulle armi in Libia
Le due criticità: l’attuazione e la difficoltà di allargare il monitoraggio alle frontiere terrestri
La prima criticità è l’attuazione. L’operazione della UE e degli Stati che hanno aderito alla decisione del Consiglio di sicurezza si limita a far rispettare l’embargo sulle armi lungo le rotte marittime. Il Consiglio di sicurezza ha invitato gli Stati a ispezionare tutti i carichi da e per la Libia “nel loro territorio, compresi porti marittimi e aeroporti” se in possesso di informazioni utili a confermare o valutare come possibile la presenza di armi. L’assenza di un quadro giuridico e di un accordo per operare in territorio libico o nei Paesi ad esso confinanti, ha dato la possibilità agli Stati decisi ad infrangere l’embargo di fornire direttamente armi alle parti in conflitto via terra, mare e aria.
La seconda criticità è rappresentata dalla possibilità di allargare il monitoraggio alle frontiere terrestri della Libia, dunque con personale UE a terra, ma solo in caso di richiesta delle autorità locali. Se fino ad oggi era difficile pensare che le due fazioni, Tobruk e il GNA di Tripoli, potessero trovassero un accordo in tal senso, il cessate il fuoco annunciato il 21 agosto da al-Sarraj e Aguila Saleh, portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, apre a qualche possibilità (un’ipotesi a cui si somma la possibilità di dimissioni da parte dello stesso al-Sarraj e di un possibile cambio alla guida del GNA, di cui sono circolate voci il 15 settembre). Ad oggi però, in assenza dell’autorizzazione del Consiglio di sicurezza o il consenso delle parti libiche, l’UE non può condurre attività di sorveglianza nello spazio aereo libico, né tanto meno fermare la fornitura di armi per via aerea o imporre l’embargo sulle armi a terra in Libia. Poiché la maggior parte delle armi destinate alle forze del generale Haftar sono trasportate via terra o via aerea, una più severa applicazione dell’embargo sulle armi in mare svantaggia in maniera rilevante il GNA che viene rifornito prevalentemente dalla Turchia attraverso la rotta marittima.
Tuttavia, ci si può chiedere se l’operazione dell’UE non sarà altro che simbolismo, poiché gli Stati membri dell’UE difficilmente saranno disposti a impegnare le risorse navali e di sorveglianza necessarie per applicare efficacemente l’embargo sulle armi.
Analisi, valutazioni, previsioni
Nonostante l’embargo sulle armi approvato dalle Nazioni Unite e parzialmente realizzato dall’operazione “Irini”, la Turchia ha firmato un accordo di cooperazione militare con il GNA e ha inviato droni, veicoli corazzati, mercenari siriani e consiglieri militari turchi a sostegno del governo libico guidato da al-Sarraj, impegnato a contrastare le forze di Haftar. Un sostegno che ha cambiato gli equilibri sul campo, imponendo al LNA di ritirarsi dall’ovest del paese dopo un tentativo fallito di catturare Tripoli, poi trasformatosi in un assedio logorante durato oltre un anno.
È chiaro che con le attuali regole non sarà possibile fermare il flusso di armi e materiali dalla Turchia che ha reso possibile la battuta d’arresto imposta al generale Haftar e consolidato la posizione e il ruolo di Ankara a Tripoli, così come confermato dalla cessione del porto di Misurata alla Turchia e il contemporaneo allontanamento dell’Italia dalla stessa area.
senza una capacità di effettivo intervento e di contrasto alle violazioni dell’embargo la deterrenza viene meno
L’obiettivo di “Irini” è la realizzazione di una barriera deterrente: ma senza una capacità di effettivo intervento e di contrasto alle violazioni dell’embargo la deterrenza viene meno e impone all’Europa una posizione dalla quale potrà al massimo documentare l’impegno bellico della Turchia, prendendo atto del suo trionfo in Libia.
L’impatto complessivo di “Irini” sugli obiettivi prioritari della missione, alla luce di un’assenza di controllo delle rotte terrestri e aeree – ma anche marittime – attraverso le quali tali equipaggiamenti possono giungere, e ad oggi giungono, alle parti in Libia, è al momento parziale. La missione UE, se è parte di una strategia ampia, che deve essere definita e implementata, allora può avere successo. Altrimenti no.
Come recentemente suggerito dall’European Council for Foreign Affairs (ECFR), l’Italia dovrebbe cogliere l’opportunità offerta dalla presidenza tedesca del Consiglio dell’Unione Europea per creare una piattaforma dalla quale possa, insieme agli alleati, far rispettare le norme internazionali sul conflitto, mediare tra i competitor internazionali impegnati ad alimentare la guerra per procura in Libia e dare il via a una nuova conferenza delle Nazioni Unite sulla Libia. Un impegno in questa direzione renderebbe vani gli sforzi della Russia, intenta a prolungare la guerra, e potrebbe colmare il vuoto tra la Turchia su un fronte e gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto sull’altro. La recente risoluzione 2473 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostegno dell’operazione “Irini” può essere un ottimo punto di partenza per rafforzare (o creare) una visione politica europea che possa trasformarsi in azione diplomatica e militare. In tale quadro, per i paesi dell’Unione sarebbe auspicabile l’avvio di una vera operazione, imparziale ed equilibrata, basata su una strategia condivisa che possa concretamente realizzare gli impegni della Conferenza di Berlino, che sono a premessa dell’operazione “Irini”. Per fare ciò, l’embargo non potrà che essere esteso alle vie di accesso aeree e terrestri, e non limitato a un mero e parziale sforzo navale (Varvelli e Megerisi, 2020).
analisi pubblicata sull’Osservatorio Strategico Ce.Mi.S.S. N° 2/2020
Principali eventi nell’area del Maghreb e del Mashreq – Agosto
La Redazione
Algeria: risposta alla crisi. L’Algeria apre al settore privato: banche, compagnie aeree, società di trasporto marittimo
L’Algeria apre al settore privato che potrà dar vita a banche e società di trasporto aereo e marittimo di merci e passeggeri: una scelta volta a ridurre la spesa, ormai non più sostenibile, di uno stato storicamente onnipresente nell’economia del paese. Una scelta che dovrebbe portare da una fallimentare e non sostenibile economia monopolistica di stato a un’econimia aperta al mercato: queste le intenzioni annunciate il 18 agosto dal presidente Abdelmadjid Tebboune. La decisione è parte di riforme più ampie per far fronte ai problemi finanziari causati dal forte calo dei proventi delle esportazioni di energia, la principale fonte di finanziamento statale. Eletto a dicembre 2019, Tebboune vuole incoraggiare gli investitori privati nel tentativo di sviluppare il settore non energetico e ridurre la dipendenza da petrolio e gas. Le riserve di valuta estera dell’Algeria sono scese a 57 miliardi di dollari da 62 miliardi di gennaio, mentre i ricavi delle esportazioni di energia dovrebbero raggiungere 24 miliardi di dollari alla fine del 2020 rispetto ai 33 miliardi nel 2019. I guadagni energetici rappresentano attualmente il 94% delle esportazioni totali e il governo mira a portare tale cifra all’80% dal prossimo anno, aumentando il valore delle esportazioni di prodotti non energetici a 5 miliardi dagli attuali 2 miliardi. Per raggiungere questo obiettivo, il governo stanzierà circa 15 miliardi di dollari per aiutare a finanziare progetti di investimento (MEMO – Middle East Monitor, 2020).
Egitto: accordo con la Grecia per la designazione di una nuova zona economica esclusiva (EEZ)
Il 6 agosto al Cairo, Grecia ed Egitto hanno firmato l’accordo per la designazione parziale di una zona economica esclusiva (EEZ) nel Mediterraneo orientale. Per Atene, l’accordo ha effettivamente annullato un accordo marittimo tra la Turchia e il GNA dello scorso anno. Questo accordo fa parte di una più ampia strategia di risoluzione di questioni bilaterali, volta a costruire alleanze con terze parti in modo da promuovere gli interessi nazionali dei due paesi, nel rispetto del diritto internazionale. È al tempo stesso un accordo che vuole porsi in linea con il diritto del mare delle Nazioni Unite, un atto di diritto internazionale in cui la Turchia è uno dei 15 paesi al mondo a non avere firmato o ratificato. L’accordo con l’Egitto è arrivato dopo che la Grecia ha firmato un precedente accordo con l’Italia, il 9 giugno, che ha di fatto esteso un accordo del 1977 tra i due stati in merito alle piattaforme continentali nel Mar Ionio.
Israele: un accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti (UAE) Mohammed bin Zayed hanno siglato un accordo di pace: Israele “sospenderà” temporaneamente l’estensione della sovranità israeliana sulla Cisgiordania, come parte di un nuovo accordo di pace. L’accordo è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Gli Emirati Arabi Uniti e Israele, in base all’accordo, scambieranno proprie ambasciate e ambasciatori. Gli UAE saranno così il terzo Paese arabo ad avviare relazioni ufficiali con Israele, dopo Egitto e Giordania. Netanyahu ha formalmente ringraziato il presidente egiziano Adel-Fattah el-Sisi e i governi di Oman e Bahrain per il loro sostegno alla normalizzazione delle relazioni tra Abu Dhabi e Gerusalemme.
Ma il presidente dell’Autorità Palestinese (AP) Mahmoud Abbas ha rigettato l’accordo di pace definendolo “un tradimento di Gerusalemme”. In una dichiarazione letta alla televisione palestinese, il portavoce di Abbas, Nabil Abu Rudeineh, ha detto: “La leadership palestinese rifiuta quanto fatto dagli Emirati Arabi Uniti e lo considera un tradimento di Gerusalemme, della moschea di Al-Aqsa e della causa palestinese. Questo accordo è un riconoscimento de facto di Gerusalemme come capitale di Israele”. L’AP ha anche annunciato che avrebbe ritirato immediatamente il proprio ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti (Fonte: agenzia di stampa palestinese Wafa). Funzionari dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) hanno respinto l’accordo, così come il gruppo militante palestinese Hamas.
Libano: l’esplosione di Beirut una svolta per il Libano?
Nel pomeriggio del 4 agosto 2020, due esplosioni sono avvenute nel porto della città di Beirut, capitale del Libano. La seconda esplosione è stata estremamente potente e ha causato almeno 177 morti, 6.000 feriti e 10-15 miliardi di dollari di danni, lasciando circa 300.000 persone senza casa. L’incidente è stata provocato dall’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio – un materiale altamente combustibile utilizzato per produrre fertilizzanti e bombe. La spaventosa negligenza che ha lasciato più di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto in condizioni climatiche inadatte, senza la supervisione di esperti, per più di sei anni è la conferma di un paese afflitto da corruzione endemica e incompetenza, devastato da decenni di conflitti settari, assenza di governance e cinici giochi politici la cui regia è nelle mani degli Stati regionali in collaborazione con gli attori interni. Aggravata dalla pandemia, la corruzione endemica e il malgoverno hanno portato l’economia nazionale alla rovina: l’ormai cronica crisi economica e sociale ha inevitabilmente portato verso il fallimento dello Stato, anche se il Libano è già da anni uno stato fallimentare.
Per mesi i prezzi dei beni sono aumentati vertiginosamente e la classe media è sprofondata nella povertà e nella disperazione. Per settimane, prima dell’esplosione, i residenti della capitale hanno manifestato contro la cattiva gestione e l’incertezza economica. Dal giorno dell’esplosione, i manifestanti hanno poi cercato di superare con la forza i cordoni della polizia e dell’esercito; in tale situazione, il parlamento libanese ha approvato lo stato di emergenza che concede ampi poteri all’esercito: limitazione di libertà di parola, di riunione e di stampa, nonché libertà per le forze armate di entrare nelle abitazioni private e arrestare chiunque sia considerato una minaccia alla sicurezza. Ma ciò non è bastato a contenere le manifestazioni di protesta; manifestazioni che hanno indotto il premier Hassan Diab e il suo gabinetto a dimettersi: ma la crisi è troppo profonda per essere risolta con un cambio di gestione.
L’impatto della crisi è forte, soprattutto nelle aree urbane. Le persone cercano di andarsene o di sopravvivere grazie al sostegno economico di parenti all’estero; altri stanno ricorrendo al sostegno di Hezbollah. Le sanzioni economiche hanno reso l’Iran meno generoso, ma Hezbollah continua a mantenere una capillare rete di clientelismo. La principale conseguenza a breve termine è la frammentazione e la criminalizzazione, alimentata da un tasso di disoccupazione tra i più elevati della regione, anche a causa dell’oltre milione e mezzo di profughi siriani (su una popolazione di 4 milioni di abitanti) che si aggiungono agli arabi palestinesi. A lungo termine, resta da vedere in quale sfera di influenza finirà il Libano:
- l’Iran sta cercando di sfruttare la situazione di stallo, ma non può alleviare il suo bisogno finanziario;
- Hezbollah ora guarda sempre più alla Cina, come il governo che sta cercando di attirare investimenti cinesi;
- la stessa Cina guarda con grande interesse alla possibilità di un ulteriore hub nel Mediterraneo orientale (oltre alle teste di ponte che ha già in Egitto e Grecia), (Holslag, 2020).
Libia: un cessate il fuoco? E la Turchia si prende Misurata
Fajez Al Sarraj ha annunciato il 21 agosto il cessate il fuoco in tutto il Paese e ha chiesto la smilitarizzazione della città di Sirte, controllata dalle forze del generale Haftar. Al Sarraj ha anche ha annunciato elezioni a marzo con “un’adeguata base costituzionale su cui le due parti concordano”. Dopo le dichiarazioni del GNA, anche Aguila Saleh, portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, ha annunciato il cessate il fuoco. “Il nuovo stop taglia la strada a ogni ingerenza straniera e si conclude con l’uscita dei mercenari dal Paese e lo smantellamento delle milizie” ha detto Saleh aggiungendo: “Cerchiamo di voltare la pagina del conflitto e aspiriamo ad un futuro di pace e alla costruzione dello Stato attraverso un processo elettorale basato sulla Costituzione“.
Secondo Ahval News, Turchia e Qatar hanno firmato un triplice accordo di cooperazione militare con il governo libico destinato a rafforzare la difesa del governo contro le forze di Khalifa Haftar e, di conseguenza la presenza e il ruolo della Turchia e del Qatar (e dunque dei gruppi islamisti) nella regione. L’accordo, annunciato il 17 agosto dal vice ministro della Difesa libico Salam Al-Namroush, realizzerà strutture militari e avvierà programmi di addestramento all’interno del Paese. Questa cooperazione includerà il finanziamento da parte del Qatar dei centri di addestramento militare e la creazione di un centro di coordinamento trilaterale e di una base navale turca nella città di Misurata. Il supporto e la consulenza saranno anche fornite alle forze governative libiche come parte dell’accordo. L’Italia, da anni presente a Misurata con un proprio ospedale militare, è stata allontanata dall’area, rendendo vani gli sforzi fatti sino a ora. Lo stesso personale italiano sarà dislocato nei pressi della capitale Tripoli.
Siria: In riduzione le truppe statunitensi in Iraq e Siria
Il comandante militare americano in Medio Oriente ha dichiarato che i livelli delle truppe statunitensi in Iraq e Siria si ridurranno molto probabilmente nei prossimi mesi, pur ammettendo di non aver ricevuto l’ordine per avviare il ritiro delle unità. Il generale Kenneth F. McKenzie Jr., capo del comando centrale del Pentagono, ha detto che le 5.200 truppe in Iraq impegnate a combattere ciò che rimane del gruppo Stato islamico e ad addestrare le forze irachene “saranno adeguate” dopo le consultazioni con il governo di Baghdad. Il generale McKenzie ha detto che si aspetta che le forze americane e le altre forze della NATO mantengano “una presenza a lungo termine” in Iraq – sia per aiutare a combattere gli estremisti islamici che per controllare l’influenza iraniana nel paese. Non è stata confermata l’entità delle forze che rimarranno in teatro, ma fonti non ufficiali riportano un totale di forze residue non inferiori a 3.500 unità statunitensi. Nonostante la richiesta del presidente Donald J. Trump, orientate a un ritiro completo di tutte le 1.000 forze americane dalla Siria, il presidente ha confermato la permanenza di circa 500 soldati, per lo più nel nord-est del paese, che assistono gli alleati curdi siriani nella lotta contro i combattenti del gruppo Stato islamico (Schmitt, 2020).
Marocco: Il Marocco e il Portogallo si impegnano a combattere la migrazione irregolare
Il Portogallo e il Marocco si sono impegnati a unire gli sforzi per frenare la migrazione irregolare: Rabat e Lisbona hanno annunciato la decisione a seguito di una videoconferenza tra il ministro degli Interni portoghese, Eduardo Cabrita, e il ministro degli Interni del Marocco, Abdelouafi Laftit. I due ministri hanno discusso di cooperazione tra il Marocco e l’Unione europea sui temi della sicurezza e hanno manifestato la disponibilità dei loro governi a “intensificare” la cooperazione in materia di sicurezza all’interno del più ampio programma UE-Marocco di prevenzione e lotta contro la “migrazione illegale e la tratta di esseri umani”. Il progressivo spostamento del flusso migratorio verso il Portogallo è direttamente collegato all’azione di contrasto attuata dal Marocco nella tratta verso la Spagna, che è stata a lungo la rotta tradizionale delle ondate di migranti irregolari (Tamba, 2020).
Tunisia: Stop alle partenze dei migranti verso l’Italia. Intanto la crisi economica peggiora
Migliaia di migranti sono sbarcati a Lampedusa e in Sicilia nei mesi di luglio e agosto. Il governatore della regione siciliana ha chiesto di proclamare lo stato di emergenza a causa degli hotspot per l’accoglienza ai migranti irregolari che hanno superato la capacità di contenimento e dal numero di migranti risultati positivi al COVID19. La maggior parte dei migranti sbarcati a Lampedusa e in Sicilia proveniva dalla Tunisia: nel 2020 quasi la metà delle oltre 16.000 persone sbarcate sulle coste italiane è partita dalla Tunisia.
A seguito delle pressioni del ministero degli Esteri italiano, il 6 agosto la Tunisia ha annunciato di aver messo a disposizione più mezzi per contrastare le partenze irregolari di migranti, in particolare: unità navali, dispositivi di sorveglianza e squadre di ricerca in prossimità dei punti di imbarco (ANSA).
Il 18 agosto, il ministro dell’Interno italiano Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno visitato Tunisi, accompagnati dal Commissario europeo per gli Affari interni Ylva Johansson e dal Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato Oliver Varhelji; al termine del’incontro il ministero dell’Interno italiano ha donato 11 milioni di euro (13 milioni di dollari) al governo tunisino da utilizzare negli sforzi per arginare il flusso di migranti.
La decisione è arrivata in un momento critico per il Paese sia a livello economico che politico. Numerose proteste sono scoppiate nel paese quest’anno a causa della diffusa e crescente disoccupazione, la mancanza di sviluppo e la carenza di servizi pubblici nel settore sanitario, elettrico e idrico. La situazione economica sta peggiorando anche in uno dei principali settori trainanti dell’economia tunisina, quello turistico dove i ricavi sono scesi del 56% a fine luglio a 1,2 miliardi di dinari contro i 2,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno (ANSA). La crisi economica è un fattore di spinta per i migranti tunisini.
A livello politico, il primo ministro designato della Tunisia Hichem Mechichi ha detto che formerà un governo puramente tecnico a seguito delle dispute tra i partiti politici sulla formazione della prossima amministrazione del paese. La decisione porterà probabilmente il primo ministro designato a confrontarsi con il partito islamista Ennahdha, il più grande gruppo politico in parlamento, che ha annunciato che si sarebbe opposto alla formazione di un governo non politico. Tuttavia, la proposta di un governo di tecnici indipendenti da partiti politici otterrà il sostegno del potente sindacato UGTT e di alcuni altri partiti, tra cui Tahya Tounes e Dustoury el Hor.